Un sagace aforisma ogni tanto,
migliora la vita come d’incanto.
LexMat
Ricordatevi che di qualsiasi scritto, dove nasce da una idea un conflitto,
bisogna coglierne della logica l'essenza, per un sano spunto di partenza.
Se non si è schiavi di una religione, una idea anche se forte,
può far utilizzo della ragione, come del pennello ne fa l'arte.
(LexMat)
Quanto rimane, è un destino dove solo la conclusione è fatale.
Ed a dispetto della morte, tutto è libertà, un mondo di cui l'uomo è il solo padrone.
(Albert Camus)
Presentazione
La Logica di Russel, il Coraggio di Camus e la Fede di Chesterton.
venerdì 29 novembre 2013
“Le vie parallele di Cioran e Leopardi”, intervista a Mario Andrea Rigoni di Antonio Castronuovo
Da "http://aforisticamente.com/2011/01/20/le-vie-parallele-di-cioran-e-leopardi-intervista-a-mario-andrea-rigoni-di-antonio-castronuovo/" :
 Luca Ormelli scrive:
Luca Ormelli scrive:
Professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di
Padova, studioso di Leopardi (a 29 anni pubblica un ampio e innovativo
saggio su “Leopardi e l’estetizzazione dell’antico“, nucleo e presupposto dei suoi successivi studi leopardiani) e scrittore di aforismi, Mario Andrea Rigoni ha
avuto il merito di aver diffuso in Italia il pensiero e l’opera di E.M.
Cioran, uno dei più grandi pensatori del novecento e cultore del
frammento (il sentimento del nulla induce Cioran a scegliere l’aforisma
visto come un “abbozzo di vertigine”, “assioma del crepuscolo”,
“sillogismo dell’amarezza” “pensiero acido che si insinua nelle cose per
disorganizzarle, perforarle, attraversarle” in contrapposizione al
linguaggio tradizionale, alla scrittura continua. Ancora Cioran
scriverà: “concepire un pensiero, un solo e unico pensiero, ma capace di
fare a pezzi l’universo”).
Nel mio precedente articolo, citando le lettere scritte da E.M. Cioran a Mario Andrea Rigoni (pubblicate da Il Notes Magico con il titolo di Mon cher Ami), ho ripercorso la storia della ricezione editoriale di Cioran in Italia. Proprio grazie a Mario Andrea Rigoni, infatti, E.M. Cioran all’inizio degli anni ottanta trova nelle edizioni Adelphi di Roberto Calasso la casa editrice ideale per i propri testi. Rigoni si mostra un traduttore tanto congeniale quanto competente e diventa ben presto il responsabile presso Adelphi della pubblicazione delle opere di Cioran.
In un altro bel libro intitolato In compagnia di Cioran, (edito anche questo dal Notes Magico di Padova nel 2004) sono raccolti molti degli scritti che Mario Andrea Rigoni ha dedicato nel corso del tempo allo scrittore franco-rumeno (che in realtà, ricordiamolo, si definisce “apolide).

In un mondo editoriale dove i libri pubblicati su Cioran sono davvero tanti (talvolta non aggiungono nulla rispetto a quanto sapevamo , tavolta aggiungono fin troppo come a esempio un libro – uscito nel 2010 in lingua italiana – che ha suscitato molte polemiche, “Per nulla al mondo. Un amore di Cioran” un carteggio epistolare tra Friedgard Thoma, giovane insegnante tedesca di filosofia e letteratura e il settuagenario Cioran che di fronte alla sensibilità e alla dolcezza della sua ammiratrice sembra accantonare per un istante la sua misantropia, lasciandosi coinvolgere in un amore platonico), In compagnia di Cioran di Mario Andrea Rigoni è uno dei pochi libri che mi sento di consigliare ai tanti lettori e ammiratori di Cioran.
Tra i diversi testi e articoli presenti nel libro In compagnia di Cioran vorrei segnalare, proprio a metà del libro, ”Le vie parallele di Cioran e Leopardi“, un intervista a Mario Andrea Rigoni da parte di Antonio Castronuovo (anche lui, come Rigoni, aforista e studioso di Cioran, autore di un altro libro che consiglio dal titolo ”Emil Michel Cioran” pubblicato da Liguori nel 2010, una lettura di Cioran attraverso la sua opera, i suoi carteggi e le sue interviste, che delinea un profilo davvero affilato del grande moralista franco-rumeno).
In pratica due dei massimi esperti di Cioran (e tra i più importanti scrittori contemporanei di aforismi), a confronto in un intervista su due grandi pensatori, Cioran e Leopardi.
Ho chiesto sia a Mario Andrea Rigoni che a Antonio Castronuovo l’autorizzazione a ri-pubblicare questa intervista nel mio blog e l’autorizzazione mi è stata accordata. Ringrazio anche la casa editrice di Padova Il notes magico per la disponibilità.
Sono entrambi maestri di lucidità – una caratteristica che non giova molto alla vita. Tuttavia la lettura dei loro scritti sortisce un esito paradossalmente corroborante e, talvolta, perfino rasserenante, come è stato più volte notato. Non bisogna inoltre dimenticare gli effetti supremamente benefici che avrebbe la loro lezione di scetticismo, se esso potesse essere praticato su scala sociale, oltre che individuale. Non c’è antidoto migliore di questo contro il fanatismo, principio di ogni violenza.
Leopardi e Cioran sono due pensatori radicali: con poche parole, e nella migliore tradizione dello stile aforistico, essi riescono a trovare subito il nucleo delle cose. L’impressione è che lo Zibaldone o le Operette morali di Leopardi riflettano un pensiero acuminato ma abbastanza meditato, mentre Cioran ferisce e dissangua di colpo e in maniera diretta. È un’impressione corretta?
Se capisco bene, ciò che lei osserva si ricollega alla differenza che corre fra un classico e un grande epigono.
Entrambi parlano nelle loro opere di suicidio, ma entrambi muoiono nel loro letto, per malattia. Ciò nonostante il tema del suicidio è nella loro prosa qualcosa di molto efficace. Crede che una mente pessimista debba necessariamente meditare sul tema del suicidio, al di là del fatto che poi lo metta in pratica o meno?
Ne sono convinto. D’altronde Cioran diceva che proprio l’idea del suicidio gli aveva consentito di non suicidarsi. A lei, che ha scritto un bel libro sul suicidio di alcuni artisti del Novecento, forse interesserà sapere che Cioran diede una volta un’interessante intervista, che non si trova nel volume degli Entretiens pubblicato da Gallimard: essa contiene osservazioni molto importanti su questo tema, dall’antichità fino a Hitler. Anche Leopardi meditò il suicidio da quando aveva vent’anni, facendone anzi un argomento ricorrente di riflessione e di poesia; non risulta tuttavia che lo abbia mai tentato, forse per le stesse ragioni delle quali parla Cioran.
Il lettore italiano conosce l’acuminata prefazione che Cioran procurò alla sua raccolta di saggi Il pensiero di Leopardi. In quelle righe si poteva vedere come Cioran considerasse Leopardi una sorta di compagno di strada, uno di quelli che magari non sono stati letti molto ma che diventano presenti nei momenti essenziali dell’esistenza. Le chiedo: Cioran parla altrove di Leopardi? E quale immagine aveva di lui?
Cioran aveva di Leopardi una conoscenza limitata, credo, ad alcuni Canti, a qualche pensiero dello Zibaldone e poco altro: per questo nei suoi libri le citazioni leopardiane si contano sulle dita di una mano. Un po’ di più ne ha saputo attraverso i miei saggi. In compenso si sentiva un affine di Leopardi nel sentimento e nella concezione della vita e aveva incorniciato il testo dell’Infinito in un quadretto, che teneva appeso su una parete del suo appartamento parigino in rue de l’Odéon.
Lei ha conosciuto Cioran di persona. Può darci un breve ricordo dell’uomo, delle sue amicizie e delle sue abitudini?
Ho fatto un ritratto di Cioran, che è anche il mio personale «esercizio di ammirazione» nei suoi confronti, in uno scritto che uscirà tra poco in un numero speciale dei «Cahiers de l’Herne» dedicato a lui. In questa sede mi limiterò a dire che era nella vita, come nella scrittura, un uomo di una totale indipendenza e di un’intensità contagiosa. Aveva modi semplici, diretti e amabili, spesso anche divertenti, allegri e ironici, che
attenuavano o correggevano la sua qohéletica malinconia. Era, oltre che un grande lettore, un conversatore magnifico, ad onta di una leggera balbuzie. Di solito ci vedevamo tra noi, ma le poche volte in cui ci siamo trovati in circostanze diverse posso testimoniare che la sua presenza risultava seducente non solo per la gente di lettere, ma anche per la gente comune. Naturalmente aveva frequentato o conosciuto un certo numero di scrittori, di alcuni dei quali era stato o era amico: da Paulhan a Saint-John Perse, da Gabriel Marcel a Beckett, da Michaux a Ionesco. So che in una determinata circostanza si era anche adoperato per procurare un incarico a Paul Celan, di cui ricordava la sensibilità scorticata (diceva che «tout le blessait»). Celan era arrivato a Parigi dopo la guerra e aveva incontrato Cioran nel 1952 (l’anno successivo avrebbe pubblicato la sua traduzione in tedesco del Précis de Décomposition). Cioran conosce molto bene anche Henry Corbin, che aveva – mi raccontò una volta – due soli interessi: la mistica islamica, naturalmente, e … i giornali pettegoli. Fu Cioran che suggerì a Corbin il titolo sotto il quale egli raccolse i suoi saggi da Gallimard: En Islam iranien. Aggiungerò che, soprattutto negli ultimi anni, Cioran riceveva molte visite di letterati nel suo appartamento di rue de l’Odéon: vi approdavano Susan Sontag come Fernando Savater, Pietro Citati come Guido Ceronetti e Roberto Calasso. In compenso Cioran non prese mai parte alla vita della cosiddetta «società letteraria», alla quale era intimamente estraneo. D’altronde è singolare e significativo che i suoi libri raggiungessero i lettori più insospettabili: gente qualsiasi come sportivi, attori o politici famosi.
Vede un Cioran nel novecento italiano?
No, ma c’è un pensatore avvicinabile a Cioran, anche se lo stile della sua prosa è più espositivo e argomentativo e meno poetico; un filosofo dapprima trascurato dalla cultura ufficiale, sia gentiliana sia crociana, oggi più noto e tuttavia ancora nell’ombra, nonostante alcuni suoi libri siano stati ristampati per merito della casa editrice Adelphi: Giuseppe Rensi. Cioran non ebbe notizia, ma lo avrebbe certamente apprezzato e amato. Rensi è il maggior rappresentante di quel “leopardismo filosofico” di cui bisognerebbe scrivere la storia.
Quali erano i vostri rapporti personali?
Avevamo un rapporto di vera amicizia e di vera intesa, con tutta la libertà e la confidenza che ne conseguivano. Ci vedevamo immancabilmente quando andavo a Parigi (una volta venne anche a trovarmi a Padova) e ci scrivevamo molto spesso. Se gli telefonavo e gli chiedevo “Je vous dérange?”, rispondeva invariabilmente con aria divertita: “Quelle idée!”. Avendo il privilegio di non lavorare, non perché fosse ricco ma perché aveva scelto di vivere “da artista” nonostante le difficoltà economiche – talvolta gravi – che ciò comportava, era sempre libero. È ovvio, inoltre, che non aveva non solo gli obblighi ma neppure la mentalità – penosa – del “lavoratore”. In ogni caso a me ha riservato un affetto e una sollecitudine commoventi. Non potrò mai dimenticare lui e Simone che si affaccendavano attorno alla macchina da scrivere (era Simone che pigiava i tasti) per migliorare la traduzione francese di qualche mio balbettio letterario.
Di che cosa parlavate tra voi?
Di tutto: dei problemi di lingua e di traduzione, naturalmente, e poi della salute, delle conoscenze comuni, di certi libri, dell’unicità storica degli ebrei, ai quali aveva dedicato il saggio più bello che io abbia mai letto in proposito: Un peuple de solitaires, contenuto in La tentation d’exister. Parlavamo della fine dell’Occidente e, già allora, dell’avanzata dell’Islam: Cioran profetizzava che un giorno Notre Dame sarebbe diventata una moschea.
Mai di avvenimenti italiani?
Parlavamo talvolta del terrorismo, che in quegli anni infuriava. Ho ritrovato quello che mi scrisse non appena fu diffusa la notizia del delitto Moro: “A l’instant, j’apprends la nouvelle terrible. Ces messieurs des Brigades, si par impossible s’emparaient de l’ Etat, infligeraient à l’Italie un régime de type cambogien. Toutes ces tragédies à cause de l’Utopie!”.
Che cosa mi può dire delle lettere di Cioran?
Nel corso della sua vita Cioran scrisse moltissime lettere, forse qualche migliaio, dato che io solo ne conservo più di cento: spero che un giorno siano raccolte e pubblicate, almeno le più notevoli. Era d’altronde uno dei generi che amava maggiormente: ne parla in un breve scritto intitolato Mania epistolare.
C’è una lettera, in particolare, che testimoni la vostra affinità su argomenti che consideravate essenziali?
Più d’una. Ricordo che una volta, non so più in quale circostanza, gli confessai la mia disperazione ed egli rispose con un’analisi di sé e di me incentrata sulla maledizione della coscienza. Diceva che gente come noi è fatta per divorare se stessa…
Che cosa le ha dato Cioran sul piano strettamente letterario?
Mi ha fatto percepire una cosa più preziosa di qualunque idea – almeno per uno scrittore o per un letterato: l’importanza del tono. Una volta mi ha detto: «Si vous avez le ton, vous avez tout».
Nelle Variazioni sull’impossibile, da lei pubblicate presso Rizzoli, emergono analogie tra il suo pensiero e quello di Leopardi e Cioran, se non altro nell’opzione pessimista che incardina i suoi aforismi. Ma vi balugina anche qualcosa di «possibile», quando ad esempio lei scrive che «l’esistenza è troppo sinistra e troppo piccante perché dietro non ci sia qualcosa». Le chiedo allora, in conclusione, se il suo pessimismo non abbia un aspetto metafisico: per andare avanti è necessario «credere», nutrire una illusione?
Le parole “pessimismo”, “pessimista”, hanno una tinta psicologica, che implica o incoraggia l’equivoco. D’altronde sono state usate da grandi pensatori, Leopardi incluso. In ogni caso lei tocca un punto profondo, che mi ossessiona da sempre. Il mio “pessimismo” è metafisico in quanto credo possibile, anzi probabile, che dietro il sipario dell’esistenza si nasconda dell’altro: ma sarebbe anche qualcosa di felice e di augurabile per noi? Il mio dubbio è che il nostro universo non rappresenti neppure il peggiore dei mondi possibili: chi può dire se non ve ne siano di ancora più neri e sgomentevoli? La sola consolazione e la sola speranza è che al terrore nel quale viviamo su questa terra si mescola sempre una misteriosa bellezza…
L’intervista è tratta dal libro “In compagnia di Cioran” edito nel 2004 da Il Notes magico, Padova.
Si ringrazia Mario Andrea Rigoni e Antonio Castronuovo per l’autorizzazione concessa alla pubblicazione.
Nel mio precedente articolo, citando le lettere scritte da E.M. Cioran a Mario Andrea Rigoni (pubblicate da Il Notes Magico con il titolo di Mon cher Ami), ho ripercorso la storia della ricezione editoriale di Cioran in Italia. Proprio grazie a Mario Andrea Rigoni, infatti, E.M. Cioran all’inizio degli anni ottanta trova nelle edizioni Adelphi di Roberto Calasso la casa editrice ideale per i propri testi. Rigoni si mostra un traduttore tanto congeniale quanto competente e diventa ben presto il responsabile presso Adelphi della pubblicazione delle opere di Cioran.
In un altro bel libro intitolato In compagnia di Cioran, (edito anche questo dal Notes Magico di Padova nel 2004) sono raccolti molti degli scritti che Mario Andrea Rigoni ha dedicato nel corso del tempo allo scrittore franco-rumeno (che in realtà, ricordiamolo, si definisce “apolide).

In un mondo editoriale dove i libri pubblicati su Cioran sono davvero tanti (talvolta non aggiungono nulla rispetto a quanto sapevamo , tavolta aggiungono fin troppo come a esempio un libro – uscito nel 2010 in lingua italiana – che ha suscitato molte polemiche, “Per nulla al mondo. Un amore di Cioran” un carteggio epistolare tra Friedgard Thoma, giovane insegnante tedesca di filosofia e letteratura e il settuagenario Cioran che di fronte alla sensibilità e alla dolcezza della sua ammiratrice sembra accantonare per un istante la sua misantropia, lasciandosi coinvolgere in un amore platonico), In compagnia di Cioran di Mario Andrea Rigoni è uno dei pochi libri che mi sento di consigliare ai tanti lettori e ammiratori di Cioran.
Tra i diversi testi e articoli presenti nel libro In compagnia di Cioran vorrei segnalare, proprio a metà del libro, ”Le vie parallele di Cioran e Leopardi“, un intervista a Mario Andrea Rigoni da parte di Antonio Castronuovo (anche lui, come Rigoni, aforista e studioso di Cioran, autore di un altro libro che consiglio dal titolo ”Emil Michel Cioran” pubblicato da Liguori nel 2010, una lettura di Cioran attraverso la sua opera, i suoi carteggi e le sue interviste, che delinea un profilo davvero affilato del grande moralista franco-rumeno).
In pratica due dei massimi esperti di Cioran (e tra i più importanti scrittori contemporanei di aforismi), a confronto in un intervista su due grandi pensatori, Cioran e Leopardi.
Ho chiesto sia a Mario Andrea Rigoni che a Antonio Castronuovo l’autorizzazione a ri-pubblicare questa intervista nel mio blog e l’autorizzazione mi è stata accordata. Ringrazio anche la casa editrice di Padova Il notes magico per la disponibilità.
****
“Le vie parallele di Cioran e Leopardi” Intervista a Mario Andrea Rigoni di Antonio Castronuovo.
Gentile prof. Rigoni, la sua
avventura intellettuale è traversata da Leopardi e da Cioran. Vorrei che
lei ci aiutasse a mettere a confronto l’uno con l’altro: che cosa li
unisce e che cosa li separa?
Condividevano l’esperienza capitale della
noia, cioè il senso della vacuità universale delle cose, che
evidentemente percepivano nella carne, oltre che nel pensiero. Erano
scettici, del tutto privi di illusioni, benché ne riconoscessero la
necessità per la vita e per la storia. Inoltre pensavano che l’uomo,
avendo deviato dal corso della natura fino a costituire una anomalia
minacciosa, andasse fatalmente incontro alla propria distruzione. È
questa l’origine del loro antistoricismo e del loro antiumanesimo
radicale. Una tale visione era però accompagnata, se non redenta, dalla
religione della poesia, della forma, dello stile: tutto lo Zibaldone di Pensieri brulica
di testimonianze di questa natura, alle quali la critica non ha mai
prestato l’attenzione dovuta. Cioran, da parte sua, diceva di sognare
un mondo dove si potrebbe morire per una virgola. Proprio una battuta
come questa si presta ad esemplificare la diversità psicologica e
storica tra Cioran e Leopardi: vi è nell’uno, interprete ed erede di
tutte le decadenze, un genio dell’esagerazione, dell’ibridazione e della
teatralità ironica estraneo alla verginità ancora classica e
settecentesca della personalità dell’altro. La stessa cosa vale
naturalmente già per Baudelaire – non a caso uno degli scrittori più
amati da Cioran.
Crede che il sistema di pensiero di Leopardi e di Cioran
possa avere effetto pratico sui loro lettori? In altre parole: cosa ci
insegnano che sia realmente applicabile alla vita?Sono entrambi maestri di lucidità – una caratteristica che non giova molto alla vita. Tuttavia la lettura dei loro scritti sortisce un esito paradossalmente corroborante e, talvolta, perfino rasserenante, come è stato più volte notato. Non bisogna inoltre dimenticare gli effetti supremamente benefici che avrebbe la loro lezione di scetticismo, se esso potesse essere praticato su scala sociale, oltre che individuale. Non c’è antidoto migliore di questo contro il fanatismo, principio di ogni violenza.
Leopardi e Cioran sono due pensatori radicali: con poche parole, e nella migliore tradizione dello stile aforistico, essi riescono a trovare subito il nucleo delle cose. L’impressione è che lo Zibaldone o le Operette morali di Leopardi riflettano un pensiero acuminato ma abbastanza meditato, mentre Cioran ferisce e dissangua di colpo e in maniera diretta. È un’impressione corretta?
Se capisco bene, ciò che lei osserva si ricollega alla differenza che corre fra un classico e un grande epigono.
Entrambi parlano nelle loro opere di suicidio, ma entrambi muoiono nel loro letto, per malattia. Ciò nonostante il tema del suicidio è nella loro prosa qualcosa di molto efficace. Crede che una mente pessimista debba necessariamente meditare sul tema del suicidio, al di là del fatto che poi lo metta in pratica o meno?
Ne sono convinto. D’altronde Cioran diceva che proprio l’idea del suicidio gli aveva consentito di non suicidarsi. A lei, che ha scritto un bel libro sul suicidio di alcuni artisti del Novecento, forse interesserà sapere che Cioran diede una volta un’interessante intervista, che non si trova nel volume degli Entretiens pubblicato da Gallimard: essa contiene osservazioni molto importanti su questo tema, dall’antichità fino a Hitler. Anche Leopardi meditò il suicidio da quando aveva vent’anni, facendone anzi un argomento ricorrente di riflessione e di poesia; non risulta tuttavia che lo abbia mai tentato, forse per le stesse ragioni delle quali parla Cioran.
Il lettore italiano conosce l’acuminata prefazione che Cioran procurò alla sua raccolta di saggi Il pensiero di Leopardi. In quelle righe si poteva vedere come Cioran considerasse Leopardi una sorta di compagno di strada, uno di quelli che magari non sono stati letti molto ma che diventano presenti nei momenti essenziali dell’esistenza. Le chiedo: Cioran parla altrove di Leopardi? E quale immagine aveva di lui?
Cioran aveva di Leopardi una conoscenza limitata, credo, ad alcuni Canti, a qualche pensiero dello Zibaldone e poco altro: per questo nei suoi libri le citazioni leopardiane si contano sulle dita di una mano. Un po’ di più ne ha saputo attraverso i miei saggi. In compenso si sentiva un affine di Leopardi nel sentimento e nella concezione della vita e aveva incorniciato il testo dell’Infinito in un quadretto, che teneva appeso su una parete del suo appartamento parigino in rue de l’Odéon.
Lei ha conosciuto Cioran di persona. Può darci un breve ricordo dell’uomo, delle sue amicizie e delle sue abitudini?
Ho fatto un ritratto di Cioran, che è anche il mio personale «esercizio di ammirazione» nei suoi confronti, in uno scritto che uscirà tra poco in un numero speciale dei «Cahiers de l’Herne» dedicato a lui. In questa sede mi limiterò a dire che era nella vita, come nella scrittura, un uomo di una totale indipendenza e di un’intensità contagiosa. Aveva modi semplici, diretti e amabili, spesso anche divertenti, allegri e ironici, che
attenuavano o correggevano la sua qohéletica malinconia. Era, oltre che un grande lettore, un conversatore magnifico, ad onta di una leggera balbuzie. Di solito ci vedevamo tra noi, ma le poche volte in cui ci siamo trovati in circostanze diverse posso testimoniare che la sua presenza risultava seducente non solo per la gente di lettere, ma anche per la gente comune. Naturalmente aveva frequentato o conosciuto un certo numero di scrittori, di alcuni dei quali era stato o era amico: da Paulhan a Saint-John Perse, da Gabriel Marcel a Beckett, da Michaux a Ionesco. So che in una determinata circostanza si era anche adoperato per procurare un incarico a Paul Celan, di cui ricordava la sensibilità scorticata (diceva che «tout le blessait»). Celan era arrivato a Parigi dopo la guerra e aveva incontrato Cioran nel 1952 (l’anno successivo avrebbe pubblicato la sua traduzione in tedesco del Précis de Décomposition). Cioran conosce molto bene anche Henry Corbin, che aveva – mi raccontò una volta – due soli interessi: la mistica islamica, naturalmente, e … i giornali pettegoli. Fu Cioran che suggerì a Corbin il titolo sotto il quale egli raccolse i suoi saggi da Gallimard: En Islam iranien. Aggiungerò che, soprattutto negli ultimi anni, Cioran riceveva molte visite di letterati nel suo appartamento di rue de l’Odéon: vi approdavano Susan Sontag come Fernando Savater, Pietro Citati come Guido Ceronetti e Roberto Calasso. In compenso Cioran non prese mai parte alla vita della cosiddetta «società letteraria», alla quale era intimamente estraneo. D’altronde è singolare e significativo che i suoi libri raggiungessero i lettori più insospettabili: gente qualsiasi come sportivi, attori o politici famosi.
Vede un Cioran nel novecento italiano?
No, ma c’è un pensatore avvicinabile a Cioran, anche se lo stile della sua prosa è più espositivo e argomentativo e meno poetico; un filosofo dapprima trascurato dalla cultura ufficiale, sia gentiliana sia crociana, oggi più noto e tuttavia ancora nell’ombra, nonostante alcuni suoi libri siano stati ristampati per merito della casa editrice Adelphi: Giuseppe Rensi. Cioran non ebbe notizia, ma lo avrebbe certamente apprezzato e amato. Rensi è il maggior rappresentante di quel “leopardismo filosofico” di cui bisognerebbe scrivere la storia.
Quali erano i vostri rapporti personali?
Avevamo un rapporto di vera amicizia e di vera intesa, con tutta la libertà e la confidenza che ne conseguivano. Ci vedevamo immancabilmente quando andavo a Parigi (una volta venne anche a trovarmi a Padova) e ci scrivevamo molto spesso. Se gli telefonavo e gli chiedevo “Je vous dérange?”, rispondeva invariabilmente con aria divertita: “Quelle idée!”. Avendo il privilegio di non lavorare, non perché fosse ricco ma perché aveva scelto di vivere “da artista” nonostante le difficoltà economiche – talvolta gravi – che ciò comportava, era sempre libero. È ovvio, inoltre, che non aveva non solo gli obblighi ma neppure la mentalità – penosa – del “lavoratore”. In ogni caso a me ha riservato un affetto e una sollecitudine commoventi. Non potrò mai dimenticare lui e Simone che si affaccendavano attorno alla macchina da scrivere (era Simone che pigiava i tasti) per migliorare la traduzione francese di qualche mio balbettio letterario.
Di che cosa parlavate tra voi?
Di tutto: dei problemi di lingua e di traduzione, naturalmente, e poi della salute, delle conoscenze comuni, di certi libri, dell’unicità storica degli ebrei, ai quali aveva dedicato il saggio più bello che io abbia mai letto in proposito: Un peuple de solitaires, contenuto in La tentation d’exister. Parlavamo della fine dell’Occidente e, già allora, dell’avanzata dell’Islam: Cioran profetizzava che un giorno Notre Dame sarebbe diventata una moschea.
Mai di avvenimenti italiani?
Parlavamo talvolta del terrorismo, che in quegli anni infuriava. Ho ritrovato quello che mi scrisse non appena fu diffusa la notizia del delitto Moro: “A l’instant, j’apprends la nouvelle terrible. Ces messieurs des Brigades, si par impossible s’emparaient de l’ Etat, infligeraient à l’Italie un régime de type cambogien. Toutes ces tragédies à cause de l’Utopie!”.
Che cosa mi può dire delle lettere di Cioran?
Nel corso della sua vita Cioran scrisse moltissime lettere, forse qualche migliaio, dato che io solo ne conservo più di cento: spero che un giorno siano raccolte e pubblicate, almeno le più notevoli. Era d’altronde uno dei generi che amava maggiormente: ne parla in un breve scritto intitolato Mania epistolare.
C’è una lettera, in particolare, che testimoni la vostra affinità su argomenti che consideravate essenziali?
Più d’una. Ricordo che una volta, non so più in quale circostanza, gli confessai la mia disperazione ed egli rispose con un’analisi di sé e di me incentrata sulla maledizione della coscienza. Diceva che gente come noi è fatta per divorare se stessa…
Che cosa le ha dato Cioran sul piano strettamente letterario?
Mi ha fatto percepire una cosa più preziosa di qualunque idea – almeno per uno scrittore o per un letterato: l’importanza del tono. Una volta mi ha detto: «Si vous avez le ton, vous avez tout».
Nelle Variazioni sull’impossibile, da lei pubblicate presso Rizzoli, emergono analogie tra il suo pensiero e quello di Leopardi e Cioran, se non altro nell’opzione pessimista che incardina i suoi aforismi. Ma vi balugina anche qualcosa di «possibile», quando ad esempio lei scrive che «l’esistenza è troppo sinistra e troppo piccante perché dietro non ci sia qualcosa». Le chiedo allora, in conclusione, se il suo pessimismo non abbia un aspetto metafisico: per andare avanti è necessario «credere», nutrire una illusione?
Le parole “pessimismo”, “pessimista”, hanno una tinta psicologica, che implica o incoraggia l’equivoco. D’altronde sono state usate da grandi pensatori, Leopardi incluso. In ogni caso lei tocca un punto profondo, che mi ossessiona da sempre. Il mio “pessimismo” è metafisico in quanto credo possibile, anzi probabile, che dietro il sipario dell’esistenza si nasconda dell’altro: ma sarebbe anche qualcosa di felice e di augurabile per noi? Il mio dubbio è che il nostro universo non rappresenti neppure il peggiore dei mondi possibili: chi può dire se non ve ne siano di ancora più neri e sgomentevoli? La sola consolazione e la sola speranza è che al terrore nel quale viviamo su questa terra si mescola sempre una misteriosa bellezza…
L’intervista è tratta dal libro “In compagnia di Cioran” edito nel 2004 da Il Notes magico, Padova.
Si ringrazia Mario Andrea Rigoni e Antonio Castronuovo per l’autorizzazione concessa alla pubblicazione.
2 risposte a “Le vie parallele di Cioran e Leopardi”, intervista a Mario Andrea Rigoni di Antonio Castronuovo
In merito a Rensi rimando i lettori di “Aforistica/mente” al mio articolo inerente un testo del filosofo veronese: http://www.lankelot.eu/letteratura/rensi-giuseppe-la-filosofia-dellassurdo.html
Ringrazio Fabrizio dell’ospitalità, L.
Ringrazio Fabrizio dell’ospitalità, L.
Conosco i libri di Cioran da 20 anni e
quelli di leopardi ancora di più. Sono due fautori di quel modo di
pensare che preferisco nel profondo dell animo. E’ estremamente
confortante sapere che qualcuno ha solidificato il tuo stesso pensare e
l’abbia fatto con il coraggio della lucidità e la leggerezza dell
‘ironia. Per usare una frase evocativa e per niente frivola ,propria
dell’aforisma secco e asciutto di Cioran che diceva, a proposito
dell’amore: ” e’ uno scambio di saliva” invece quando gli si chiedeva
come si sentisse , rispondeva perentorio: “mi sento come una puttana
senza marciapiede”. Leopardi invece l’ho letto sempre con avidita’
curiosa. Sempre pronto a scovare la paura di vivere nelle pieghe dei
suoi scritti, ma sbagliavo nella intenzione, aveva invece la forza
tragica del poeta solitario e imbelle. E’ stato al pari di Cioran figlio
di un’epoca che accomuna tutta l’umanità, anche se l’uomo medio,
concreto e distante dal pensarsi addosso, schiva certo tipo di
letteratura e filosofia.Posso dire concludendo che sono orgoglioso di
cibarmi dei loro libri e sapere che da qualche parte il mio intimo
pensiero ha trovato delle voci eccelse. F.P.
Cioran e la sua ricezione in Italia attraverso la testimonianza delle lettere a Mario Andrea Rigoni
Da "http://aforisticamente.com/2011/01/17/e-m-cioran-la-sua-ricezione-in-italia-attraverso-le-lettere-a-mario-andrea-rigoni/" :
In un genere emarginato e nascosto come quello aforistico, Emil Cioran, o meglio E.M. Cioran (“ho rinunciato al mio nome di battesimo e al suo posto metto sempre le iniziali E.M. A ognuno le sue manie” scrive in una lettera all’amico e studioso Mario Andrea Rigoni) è forse uno degli scrittori di aforismi e forme brevi più conosciuti e letti (mi esimo dall’aggiungere anche “grande” dal momento che in un’altra sua lettera a Rigoni Cioran scrive “Ho un solo suggerimento da darle: se non è troppo tardi bisognerebbe sopprimere grande nell’espressione ‘il grande scrittore romeno-parigino’. Sono realmente sincero, e non si tratta di modestia calcolata“).
In Italia la casa editrice Adelphi ha pubblicato quasi tutte le opere di Cioran (libri come Al Culmine della disperazione, Sillogismi dell’amarezza o L’inconveniente di essere nati hanno anche registrato un ampio successo di vendite), critici e studiosi citano continuamente opere e frammenti e sul web gli aforismi e i frammenti di Cioran rimbalzano, in modo quasi ossessivo, da un sito all’altro.
Non è mia intenzione in questo articolo riprodurre una selezione – l’ennesima – di aforismi cioraniani né scrivere una recensione – l’ennesima – sull’opera di Cioran (“Qui si sono scritti una ventina di articoli sul mio ultimo libro: cosa da disgustarmi per sempre di scrivere” scrive Cioran in una lettera).
Vorrei piuttosto parlare di Cioran attraverso un punto di vista particolare: la sua amicizia con Mario Andrea Rigoni, studioso di letteratura italiana (in particolare su Leopardi) e scrittore di aforismi.
Pochi sanno che, proprio grazie a Mario Andrea Rigoni, E.M. Cioran all’inizio degli anni ottanta trova nelle edizioni Adelphi di Roberto Calasso la casa editrice ideale per i propri testi (“Proprio oggi ho scritto due righe a Roberto Calasso, che conoscevo da un po’ di tempo grazie alle Sue lettere. Non dimentico che, se Adelphi ha deciso di pubblicarmi, è soprattutto merito Suo” scrive Cioran a Rigoni). Rigoni si mostra un traduttore tanto congeniale quanto competente (“perchè lei conosce mirabilmente il francese, ogni volta che ricevo una sua traduzione, respiro” gli scrive Cioran da Parigi) e diventa ben presto il responsabile presso Adelphi della pubblicazione delle opere di Cioran scrivendone anche alcune illuminanti prefazioni (pochi l’avranno notato ma all’inizio delle edizioni Adelphi c’è la scritta: “La pubblicazione delle opere di E.M Cioran avviene sotto la direzione di M.A. Rigoni”).
In un bellissimo libro intitolato “E.M. Cioran Mon cher ami, lettere a Mario Andrea Rigoni 1977-1990“, pubblicato da una piccola casa editrice di Padova Il notes magico con una splendida introduzione di Raoul Bruni, viene raccolta un’ampia scelta delle lettere che E.M. Cioran scrive a Mario Andrea Rigoni, nell’arco di tredici anni, tra il 1977 e il 1990. L’epistolario tra uno dei massimi scrittori contemporanei e il giovane studioso e scrittore di aforismi ripercorre la storia di questa amicizia (quando il carteggio prende avvio, Rigoni, allora ventinovenne, aveva pubblicato da poco un ampio e innovativo saggio su Leopardi e l’estetizzazione dell’antico) e soprattutto fa luce sulla storia, tutt’altro che lineare, della ricezione di Cioran in Italia.
In una lettera a Rigoni del 1977 Cioran scriverà: “So di non esistere in Italia. Ma ciò fa parte di un fallimento letterario che accetto, d’altronde sono un autore marginale e tale mi considero“. Come scrive Raoul Bruni nell’introduzione all’epistolario, “Se in generale sul rapporto di Cioran con gli editori sembra incombere una ‘sorta di grottesca sfortuna’ al punto che egli potrebbe scrivere un libro intero sulle sue noie con loro (“pensi che in America e in Germania mi hanno pubblicato presso case editrici specializzate in libri scolastici. E’ pura follia” scrive Cioran a Rigoni) in Italia tale sfortuna editoriale assume caratteri particolari”. I primi due libri di Cioran (Le mauvais démiurge e Histoire et Utopie) furono avventuruosamente tradotti e stampati agli inizi degli anni sessanta dalle Edizioni del Borghese, notoriamente di destra (dalle lettere a Rigoni risulta che Cioran non nutriva simpatia per questo editore da cui in seguito si allontanerà). In seguito si farà avanti, con la proposta di tradurne i libri una casa milanese esordiente, Multhipla, vicina all’estrema sinistra. Dopo un primo momento di esitazione, Cioran rifiuterà l’offerta di Multhipla (“Multhipla rischia di sparire tra qualche mese, come accade spesso alle imprese di questo genere. Uno scrittore sconosciuto in una casa editrice sconosciuta assomiglia troppo alle mie peripezie, al mio passato” scrive Cioran). Se tale decisione era dovuta alla legittima diffidenza di Cioran per le case editrici piccole, Multhipla (come del resto Edizioni del Borghese) non poteva rappresentare l’editore auspicato anche per altre ragioni. “Le consiglio di tener conto dell’orientamento della rivista, e di conseguenza di escludere dalla scelta che sta per fare tutto ciò che da vicino o da lontano tocca la politica, le ideologie e le insensatezze di questo tipo” scriverà Cioran in una sua lettera a Rigoni.
Fu grazie a Rigoni che in Italia Cioran uscirà dall’isolamento editoriale. Il primo scritto di Rigoni su Cioran risale al 1980, allorché pubblica su Nuovi Argomenti una Piccola antologia cioraniana, cui antepone una breve premessa intitolata Il funambolo dell’intollerabile che Cioran mostrò di apprezzare (“Che trovata! Le formule ben coniate sono possibili soltanto nelle lingue latine” scriverà a Rigoni). In ambito italiano questa antologia precede di un anno l’uscita presso Adelphi dei primi libri di Cioran tradotti da Rigoni: Ecartelèment (Squartamento, 1981 con un saggio introduttivo di Guido Ceronetti) et Historie et Utopie (Storia e Utopia, 1982). Poi uscirono le altre opere sotto la direzione di Rigoni, che cordinò anche le traduzioni (tra tutti quella di Luigia Zilli, traduttrice di L’inconveniente di essere nati, “probabilmente il libro che mi esprime meglio” come scrive Cioran).
L’epistolario “Mon cher Ami” è interessante per ciò che rivela sulla persona di Cioran (il suo presunto nichilismo è temperato dal senso dell’ironia, da una grande comprensione per le debolezze umane e, soprattutto, dall’affetto per il giovane Mario Andrea Rigoni. Sorprende leggere, per esempio, da parte di un Cioran che ha ha scritto un libro su “L’inconveniente di essere nati“, i calorosi auguri rivolti a Rigoni in occasione della nascita del figlio).
Come scrivevo sopra – una parte consistente delle lettere indirizzate da Cioran a Rigoni verte su discussioni inerenti alla pubblicazione e al rapporto con gli editori. Rigoni e Cioran discutono spesso anche di questioni relative alla traduzione dei libri di ambedue. Cioran sostiene a più riprese di non conoscere davvero l’italiano, ma di riuscire solo a “indovinarlo”, grazie alla conoscenza del romeno (e ovviamente del francese e dello spagnolo), ma al lettore è permesso dubitarne, visto che successivamente aiuterà il traduttore francese ad aggiustare alcuni dettagli nella versione francese dei saggi di Rigoni.
Per un appassionato dell’aforisma come me, Mon Cher ami è anche ricco di spunti e riflessioni sul genere aforistico. Scorrendo l’epistolario mi sono imbattuto in veri e propri aforismi o frammenti della stessa natura di quelli che si leggono nelle opere di Cioran. In particolare c’è un aforisma sull’aforisma (chi conosce il mio blog sa che sono un vero e proprio collezionista), scritto da Cioran in una delle primissime lettere (8, settembre, 1977) che è esemplare per la sua lucidità: “Il genere dell’aforisma comporta delle difficoltà, poiché la parola ha maggiore importanza che in una poesia o in un contratto. In realtà è tutto.E’ questa la punizione di chi coltiva una forma di espressione in apparenza così poco seria“. Come scrive bene Raoul Bruni, Cioran è uno degli ultimi continuatori della grande tradizione epistolografica europea, una tradizione che passa attraverso Madame Du Deffand, Flaubert, Kafka e Rilke, e vede tra i suoi massimi rappresentanti italiani, guarda caso, Leopardi.
In un modo letterario così pieno di rumore e di ridondanze, dove Cioran viene citato a sproposito per qualunque cosa, questo epistolario tra Cioran e Rigoni, mi sembra un ottimo punto di osservazione – discreto e nascosto ma anche così lucidamente obiettivo – per conoscere Cioran al di là dei tanti luoghi comuni che ne circondano la fama.
In un genere emarginato e nascosto come quello aforistico, Emil Cioran, o meglio E.M. Cioran (“ho rinunciato al mio nome di battesimo e al suo posto metto sempre le iniziali E.M. A ognuno le sue manie” scrive in una lettera all’amico e studioso Mario Andrea Rigoni) è forse uno degli scrittori di aforismi e forme brevi più conosciuti e letti (mi esimo dall’aggiungere anche “grande” dal momento che in un’altra sua lettera a Rigoni Cioran scrive “Ho un solo suggerimento da darle: se non è troppo tardi bisognerebbe sopprimere grande nell’espressione ‘il grande scrittore romeno-parigino’. Sono realmente sincero, e non si tratta di modestia calcolata“).
In Italia la casa editrice Adelphi ha pubblicato quasi tutte le opere di Cioran (libri come Al Culmine della disperazione, Sillogismi dell’amarezza o L’inconveniente di essere nati hanno anche registrato un ampio successo di vendite), critici e studiosi citano continuamente opere e frammenti e sul web gli aforismi e i frammenti di Cioran rimbalzano, in modo quasi ossessivo, da un sito all’altro.
Non è mia intenzione in questo articolo riprodurre una selezione – l’ennesima – di aforismi cioraniani né scrivere una recensione – l’ennesima – sull’opera di Cioran (“Qui si sono scritti una ventina di articoli sul mio ultimo libro: cosa da disgustarmi per sempre di scrivere” scrive Cioran in una lettera).
Vorrei piuttosto parlare di Cioran attraverso un punto di vista particolare: la sua amicizia con Mario Andrea Rigoni, studioso di letteratura italiana (in particolare su Leopardi) e scrittore di aforismi.
Pochi sanno che, proprio grazie a Mario Andrea Rigoni, E.M. Cioran all’inizio degli anni ottanta trova nelle edizioni Adelphi di Roberto Calasso la casa editrice ideale per i propri testi (“Proprio oggi ho scritto due righe a Roberto Calasso, che conoscevo da un po’ di tempo grazie alle Sue lettere. Non dimentico che, se Adelphi ha deciso di pubblicarmi, è soprattutto merito Suo” scrive Cioran a Rigoni). Rigoni si mostra un traduttore tanto congeniale quanto competente (“perchè lei conosce mirabilmente il francese, ogni volta che ricevo una sua traduzione, respiro” gli scrive Cioran da Parigi) e diventa ben presto il responsabile presso Adelphi della pubblicazione delle opere di Cioran scrivendone anche alcune illuminanti prefazioni (pochi l’avranno notato ma all’inizio delle edizioni Adelphi c’è la scritta: “La pubblicazione delle opere di E.M Cioran avviene sotto la direzione di M.A. Rigoni”).
In un bellissimo libro intitolato “E.M. Cioran Mon cher ami, lettere a Mario Andrea Rigoni 1977-1990“, pubblicato da una piccola casa editrice di Padova Il notes magico con una splendida introduzione di Raoul Bruni, viene raccolta un’ampia scelta delle lettere che E.M. Cioran scrive a Mario Andrea Rigoni, nell’arco di tredici anni, tra il 1977 e il 1990. L’epistolario tra uno dei massimi scrittori contemporanei e il giovane studioso e scrittore di aforismi ripercorre la storia di questa amicizia (quando il carteggio prende avvio, Rigoni, allora ventinovenne, aveva pubblicato da poco un ampio e innovativo saggio su Leopardi e l’estetizzazione dell’antico) e soprattutto fa luce sulla storia, tutt’altro che lineare, della ricezione di Cioran in Italia.
In una lettera a Rigoni del 1977 Cioran scriverà: “So di non esistere in Italia. Ma ciò fa parte di un fallimento letterario che accetto, d’altronde sono un autore marginale e tale mi considero“. Come scrive Raoul Bruni nell’introduzione all’epistolario, “Se in generale sul rapporto di Cioran con gli editori sembra incombere una ‘sorta di grottesca sfortuna’ al punto che egli potrebbe scrivere un libro intero sulle sue noie con loro (“pensi che in America e in Germania mi hanno pubblicato presso case editrici specializzate in libri scolastici. E’ pura follia” scrive Cioran a Rigoni) in Italia tale sfortuna editoriale assume caratteri particolari”. I primi due libri di Cioran (Le mauvais démiurge e Histoire et Utopie) furono avventuruosamente tradotti e stampati agli inizi degli anni sessanta dalle Edizioni del Borghese, notoriamente di destra (dalle lettere a Rigoni risulta che Cioran non nutriva simpatia per questo editore da cui in seguito si allontanerà). In seguito si farà avanti, con la proposta di tradurne i libri una casa milanese esordiente, Multhipla, vicina all’estrema sinistra. Dopo un primo momento di esitazione, Cioran rifiuterà l’offerta di Multhipla (“Multhipla rischia di sparire tra qualche mese, come accade spesso alle imprese di questo genere. Uno scrittore sconosciuto in una casa editrice sconosciuta assomiglia troppo alle mie peripezie, al mio passato” scrive Cioran). Se tale decisione era dovuta alla legittima diffidenza di Cioran per le case editrici piccole, Multhipla (come del resto Edizioni del Borghese) non poteva rappresentare l’editore auspicato anche per altre ragioni. “Le consiglio di tener conto dell’orientamento della rivista, e di conseguenza di escludere dalla scelta che sta per fare tutto ciò che da vicino o da lontano tocca la politica, le ideologie e le insensatezze di questo tipo” scriverà Cioran in una sua lettera a Rigoni.
Fu grazie a Rigoni che in Italia Cioran uscirà dall’isolamento editoriale. Il primo scritto di Rigoni su Cioran risale al 1980, allorché pubblica su Nuovi Argomenti una Piccola antologia cioraniana, cui antepone una breve premessa intitolata Il funambolo dell’intollerabile che Cioran mostrò di apprezzare (“Che trovata! Le formule ben coniate sono possibili soltanto nelle lingue latine” scriverà a Rigoni). In ambito italiano questa antologia precede di un anno l’uscita presso Adelphi dei primi libri di Cioran tradotti da Rigoni: Ecartelèment (Squartamento, 1981 con un saggio introduttivo di Guido Ceronetti) et Historie et Utopie (Storia e Utopia, 1982). Poi uscirono le altre opere sotto la direzione di Rigoni, che cordinò anche le traduzioni (tra tutti quella di Luigia Zilli, traduttrice di L’inconveniente di essere nati, “probabilmente il libro che mi esprime meglio” come scrive Cioran).
L’epistolario “Mon cher Ami” è interessante per ciò che rivela sulla persona di Cioran (il suo presunto nichilismo è temperato dal senso dell’ironia, da una grande comprensione per le debolezze umane e, soprattutto, dall’affetto per il giovane Mario Andrea Rigoni. Sorprende leggere, per esempio, da parte di un Cioran che ha ha scritto un libro su “L’inconveniente di essere nati“, i calorosi auguri rivolti a Rigoni in occasione della nascita del figlio).
Come scrivevo sopra – una parte consistente delle lettere indirizzate da Cioran a Rigoni verte su discussioni inerenti alla pubblicazione e al rapporto con gli editori. Rigoni e Cioran discutono spesso anche di questioni relative alla traduzione dei libri di ambedue. Cioran sostiene a più riprese di non conoscere davvero l’italiano, ma di riuscire solo a “indovinarlo”, grazie alla conoscenza del romeno (e ovviamente del francese e dello spagnolo), ma al lettore è permesso dubitarne, visto che successivamente aiuterà il traduttore francese ad aggiustare alcuni dettagli nella versione francese dei saggi di Rigoni.
Per un appassionato dell’aforisma come me, Mon Cher ami è anche ricco di spunti e riflessioni sul genere aforistico. Scorrendo l’epistolario mi sono imbattuto in veri e propri aforismi o frammenti della stessa natura di quelli che si leggono nelle opere di Cioran. In particolare c’è un aforisma sull’aforisma (chi conosce il mio blog sa che sono un vero e proprio collezionista), scritto da Cioran in una delle primissime lettere (8, settembre, 1977) che è esemplare per la sua lucidità: “Il genere dell’aforisma comporta delle difficoltà, poiché la parola ha maggiore importanza che in una poesia o in un contratto. In realtà è tutto.E’ questa la punizione di chi coltiva una forma di espressione in apparenza così poco seria“. Come scrive bene Raoul Bruni, Cioran è uno degli ultimi continuatori della grande tradizione epistolografica europea, una tradizione che passa attraverso Madame Du Deffand, Flaubert, Kafka e Rilke, e vede tra i suoi massimi rappresentanti italiani, guarda caso, Leopardi.
In un modo letterario così pieno di rumore e di ridondanze, dove Cioran viene citato a sproposito per qualunque cosa, questo epistolario tra Cioran e Rigoni, mi sembra un ottimo punto di osservazione – discreto e nascosto ma anche così lucidamente obiettivo – per conoscere Cioran al di là dei tanti luoghi comuni che ne circondano la fama.
5 risposte a E.M. Cioran: la sua ricezione in Italia attraverso la testimonianza delle lettere a Mario Andrea Rigoni
Frege, Senso e Riferimento
Da "http://etexts.free.fr/filos/contemporanei/Frege,%20Senso%20e%20riferimento.php" :
(Titolo originale Über Sinn und Bedeutung, Ztschr. f. Philos. u. philos. Kritik, NF 100, 1892, p. 25-50)
(Titolo originale Über Sinn und Bedeutung, Ztschr. f. Philos. u. philos. Kritik, NF 100, 1892, p. 25-50)
Da Logica
e aritmetica, Scritti raccolti a cura di Corrado Mangione, Boringhieri,
Torino 1965, pp. 374-404.
Questo
notevole studio, pubblicato nel 1892, contiene un esame sottilissimo del
principio di identità dal punto di vista della logica formale moderna.
Le
difficoltà insite in tale principio vengono risolte da Frege facendo ricorso
alla distinzione fra senso e significato.
Il capitolo
presenta uno speciale interesse sotto vari aspetti:
- perché ci offre l'esempio di un'analisi logica ricca di motivi che riguardano la filosofia generale;
- perché quest'analisi è svolta in modo assai piano, con esempi concreti e comprensibili a tutti, senza far ricorso - come si suole nella maggior parte dei trattati moderni - all'ausilio di lingue simboliche, sempre un po' ostiche per i non specialisti; ciò malgrado essa è svolta con una precisione, un rigore e un acume ben difficili a superarsi;
- perché ci addita la possibilità di una sintassi logica del linguaggio, assai più profonda che la sintassi conosciuta dai filologi, e assai più capace di essa a penetrare nelle complicatissime forme del pensiero espresso. A un primo sguardo, questo carattere grammaticale della discussione può talvolta celarne il significato filosofico; quest'impressione scompare però a una lettura più approfondita e scrupolosa.
La necessità
di distinguere senso e significato può dirsi, ormai, comunemente ammessa da
tutti i logici, sebbene, a volte, enunciata con parole alquanto diverse. Quanto
poi alla sintassi logica, essa costituisce oggi, non più una semplice
possibilità, ma un programma comune a molti ricercatori, anzi la bandiera
ideale di un intero indirizzo filosofico. E proprio la scoperta ditale sintassi
filosofica che dà a tutta l'opera di Frege quel carattere così vivo e moderno
su cui abbiamo tante volte insistito.
E in base ad
essa che il suo platonismo poté diventare il punto di partenza di indirizzi
così schiettamente antimetafisici, come per esempio il già citato Circolo
Viennese. [375] Le osservazioni più importanti sono contenute nei paragrafi 1,
2, 4, 5, 12; fra essi il più originale è il paragrafo 5, che analizza il
significato delle proposizioni in rapporto con il loro valore di verità. Il
paragrafo 3 esamina di nuovo le differenze fra concetto e rappresentazione già
esposte nel capitolo secondo di questa parte seconda. I paragrafi 6- 11, un po'
meno interessanti degli altri, fanno corpo a sé, e contengono una complicata
analisi del significato delle proposizioni secondarie. A una prima lettura
possono anche venir tralasciati, senza che risulti da ciò impedita la
comprensione generale del capitolo;
1. L'analisi
dell'uguaglianza [2]
ci conduce a riflettere su alcuni problemi che si connettono a essa e sono ben
difficili a risolversi. Dobbiamo vedere nell'uguaglianza un rapporto? E
precisamente di che tipo? Un rapporto fra oggetti ovvero un rapporto fra nomi
(o segni) di oggetti?
In un
precedente lavoro [3]
mi ero pronunciato in favore di ques'ultima soluzione (che l'uguaglianza sia un
rapporto fra nomi). Ecco il principale motivo che sembra militare in favore di
essa: a = a e a = b sono palesemente due proposizioni di valore conoscitivo
diverso, poiché a = a vale a priori e deve chiamarsi, secondo Kant, analitica,
mentre proposizioni della forma a = b contengono spesso ampliamenti notevoli
della nostra conoscenza e non sempre possono venir fondate a priori. (Per
esempio la scoperta che ogni mattina non sorge un nuovo sole, ma sempre il
medesimo, è stata senza dubbio una delle più feconde dell'astronomia; e oggi
ancora il riconoscere che in diverse osservazioni abbiamo a che fare con lo
stesso piccolo pianeta o, con la stessa cometa è talvolta tutt'altro che
facile.) Orbene: se volessimo vedere nell'uguaglianza un rapporto effettivo,
non fra i nomi a e b, ma fra gli oggetti da essi designati, scomparirebbe
ovviamente ogni diversità fra le due proposizioni a = a e a = b, nel caso - ben
inteso - che l'oggetto a sia proprio uguale all'oggetto b. In tal caso infatti
l'uguaglianza esprimerebbe un rapporto di un oggetto con sé stesso e
precisamente un rapporto sui generis in cui ogni cosa sta con sé
medesima, ma nessuna con un'altra.
Ciò che si
vuol dire con la proposizione a = b sembra dunque [376] essere questo: che i
segni (o nomi) a e b significano la stessa cosa. L'uguaglianza parlerebbe
proprio di tali segni, affermerebbe un rapporto fra essi (e non fra gli oggetti).
Il rapporto
di uguaglianza sussisterebbe però fra due nomi o segni diversi solo in quanto
essi denominano o designano qualcosa. Sarebbe cioè un rapporto che dipende
dalla connessione di ognuno dei due segni con il medesimo oggetto designato. È
chiaro tuttavia che, se fosse proprio così, il rapporto di uguaglianza
risulterebbe per sua natura qualcosa di arbitrario: non si può invero proibire
a nessuno di assumere a suo arbitrio per segno di un oggetto un qualsiasi altro
oggetto o evento. Dunque, se fosse vero che il rapporto dl uguaglianza dipende
soltanto da quella connessione, l'asserto a = b riguarderebbe, non la cosa
stessa, ma soltanto il modo di scegliere i nostri segni; non potrebbe quindi
esprimere alcuna conoscenza. Sta invece il fatto che, in molti casi, con la
proposizione a = b noi vogliamo esprimere proprio una conoscenza.
Se il segno
a si distinguesse dal segno b soltanto come oggetto (e cioè - nel presente caso
- per il fatto che le due lettere a e b hanno materialmente una forma diversa),
e non si distinguesse invece in quanto segno (cioè per il modo in cui le due
lettere a e b designano un determinato oggetto), è chiaro che il valore
conoscitivo della proposizione a = b dovrebbe risultare essenzialmente identico
al valore della proposizione a = a (sempre - ben inteso - nell'ipotesi che a
sia davvero eguale a b).[4]
I due valori
delle proposizioni a = a e a = b possono risultare diversi unicamente nel caso
che la differenza del segno rispecchi un'effettiva diversità nel modo di
designare l'oggetto. Come ciò possa accadere, ce lo spiegherà il seguente
esempio. Siano r, s, t le tre mediane di un triangolo. Il punto di incontro
delle prime due coincide, com'è noto, con il punto d'incontro della seconda con
la terza. Abbiamo qui pertanto due nomi diversi che indicano lo stesso oggetto:
punto di incontro di r ed s e punto di incontro di s e t. Tali nomi (mentre [377]
ci designano lo stesso oggetto) indicano anche il modo particolare con cui
questo oggetto ci viene dato, e di conseguenza la proposizione contiene
un'effettiva conoscenza.
Ci troviamo
dunque indotti a concludere che, pensando a un segno (sia esso un nome, o un
nesso di più parole, o una semplice lettera), dovremo collegare a esso due cose
distinte: e cioè, non soltanto l'oggetto designato, che si chiamerà significato
di quel segno, ma anche il senso del segno, che denota il modo come
quell'oggetto ci viene dato. Per esempio, nel caso anzidetto delle mediane r,
s, t, il significato dell'espressione punto di incontro di r ed s è identico a
quello dell'espressione punto di incontro di s e t; il loro senso invece è
diverso. Analogamente per le espressione stella della sera e stella del
mattino; esse designano l'identica stella e perciò hanno il medesimo
significato [riferimento], ma hanno invece, com'è ovvio, un senso diverso.
Si ricava da
quel che ho detto finora, che per segno o nome intendo qui una qualunque
indicazione la quale compia l'ufficio di nome proprio, il cui significato cioè
sia un oggetto determinato (ove si intenda la parola oggetto nel modo più
ampio).
L'indicazione
di un singolo oggetto può anche consistere di più parole o altri segni. Per
brevità la chiameremo sempre nome proprio.
Il senso di
un nome proprio è qualcosa che viene subito afferrato da chi conosca
sufficientemente la lingua (o, in genere, il complesso di segni) a cui quel
nome proprio appartiene.5
Esso però non riesce a chiarire, se non da un unico lato, il significato -
posto che ve ne sia uno - del nome proprio cui si riferisce. Per conoscere
appieno tale significato, bisognerebbe essere in grado di decidere, dato un
qualunque senso, se esso si addica o no al significato anzidetto. A ciò
tuttavia non perveniamo mai.[378]
2. I rapporti che normalmente
intercorrono fra il segno, il suo senso, e il suo significato sono questi: a un
dato segno corrisponde in genere un senso determinato, e a questo corrisponde
di nuovo un significato determinato; invece a un dato significato (cioè ad un
dato oggetto) non corrisponde sempre un unico senso. Anche a un dato senso non
corrisponde un unico segno: esso infatti viene espresso in modi diversi nelle
diverse lingue, e talvolta persino nella stessa lingua.
Naturalmente
vi sono eccezioni che si staccano da questo comportamento regolare. In un
insieme completo di segni, a ogni espressione dovrebbe corrispondere - come s'è
detto - un senso determinato; però nelle lingue popolari il più delle volte
questa condizione non è soddisfatta, e si dovrebbe già esser contenti se,
almeno nella stessa frase, la medesima parola avesse sempre il medesimo senso.
Si può
ammettere forse che un'espressione la quale compia l'ufficio di nome proprio
possegga sempre un senso, se costruita in modo grammaticalmente esatto. Ciò non
implica, tuttavia, che al suo senso corrisponda sempre un significato. Per
esempio, l'espressione il corpo celeste più lontano dalla Terra ha un senso; ma
è molto dubbio che abbia pure un significato. Così, l'espressione la serie meno
convergente ha un senso; ma si dimostra che non ha alcun significato, perché -
data una qualunque serie convergente - se ne può sempre trovare un'altra,
ancora convergente, ma pure meno della prima. Dal fatto, dunque, che si afferrò
il senso di un'espressione, non ne segue ancora che essa abbia certamente un
significato.
Ordinariamente,
quando si usa una parola, ciò di cui si vuole parlare è il suo significato. Può
accadere però che si voglia invece parlare, o della parola stessa, o del suo
senso. Facciamo, per esempio, riferimento alla parola stessa allorché citiamo
le parole di un altro con discorso diretto. In questo caso le nostre parole
designano, innanzi tutto, le parole stesse pronunciate dall'altro, e soltanto
queste hanno poi (in quanto vennero pronunciate dall'altro) il loro significato
comune.
Abbiamo
allora dei segni di segni. Per riflettere questa circostanza nella scrittura,
si racchiudono fra virgolette le parole in questione. Pertanto la parola
racchiusa fra virgolette non può venir presa nel significato comune. 379 Quando
invece ci si vuoi riferire al senso di un'espressione A, si può senz'altro far
uso della locuzione il senso di A.
Il discorso
indiretto tratta in genere del senso delle proposizioni, per esempio del senso
di un discorso di un altro. È quindi chiaro che in questo tipo di discorso le
parole non hanno il loro significato ordinario, ma denotano ciò che,
ordinariamente, costituisce il loro senso. Per dirla in breve: le parole nel
discorso indiretto vengono usate direttamente, ovvero hanno un significato
indiretto. Noi distinguiamo dunque il significato ordinario di una parola dal
suo significato indiretto, e il suo senso ordinario dal suo senso indiretto. Il
significato indiretto è il suo senso ordinario.
Ritengo non
si debbano dimenticare le eccezioni qui riferite, se si vogliono comprendere
esattamente, nei singoli casi, i rapporti precisi fra segno, senso, e
significato.
3. Dal significato e dal senso di un
segno va poi tenuta ben distinta la rappresentazione che lo accompagna. Se il
significato di un segno è un oggetto percepibile coi sensi, la rappresentazione
che ho di esso è invece una mia immagine, originatasi dal ricordo sia delle
impressioni sensoriali da me provate sia delle attività, tanto interne quanto
esterne, da me esercitate [6].
Questa immagine è spesso mescolata a sentimenti; la chiarezza delle singole
parti è diversa e fluttuante. Al medesimo senso non si collega sempre la
medesima rappresentazione, neanche nella stessa persona. Essa è poi
eminentemente soggettiva variando da uomo a uomo. Per esempio un pittore, un
cavallerizzo, uno zoologo collegheranno, con tutta probabilità,
rappresentazioni assai diverse al nome Bucefalo. Questo fatto distingue in modo
essenziale la rappresentazione, non solo dal significato, ma anche dal senso di
un segno; il senso non costituisce invero, come l'immagine anzidetta, qualcosa
di inscindibile dal singolo individuo, ma può formare il possesso comune di
molti. Che sia così, ce lo prova l'esistenza di un patrimonio di pensieri 380
comuni all'umanità, patrimonio che essa trasmette di generazione in generazione
[7].
Sarebbe quindi poco opportuno designare con il medesimo nome di rappresentazione
una cosa che risulta così profondamente diversa da essa.
Mentre non
vi è alcuna incertezza nel parlare sic et sempliciter del senso di un segno,
non si può invece parlare - per quel che abbiamo spiegato - di una
rappresentazione (rigorosamente intesa) senza precisare a chi appartenne e in
quale istante gli appartenne. Si obietterà forse: come alla stessa parola l'uno
collega una rappresentazione e l'altro un'altra, così può anche darsi che l'uno
le connetta un senso e l'altro uno diverso. In questo caso però la differenza
consiste solo nel modo di attuare questa connessione. Ciò non impedisce che
entrambi afferrino il medesimo senso; mentre è impossibile che essi abbiano la
stessa rappresentazione. Si duo idem faciunt, non est idem. Se due si rappresentano
la stessa cosa, ciascuno ha tuttavia la propria rappresentazione.
Certamente
talvolta è possibile stabilire alcune distinzioni fra le rappresentazioni dei
diversi uomini, e persino fra le loro sensazioni; non è però possibile un
esatto confronto fra di esse, non potendosi avere contemporaneamente queste
rappresentazioni nella stessa coscienza.
Il
significato di un nome proprio è l'oggetto che noi indichiamo con esso; la
rappresentazione che ne abbiamo è invece completamente soggettiva. Fra l'uno e l'altra
sta il senso, che non è più soggettivo come la rappresentazione, ma non
coincide nemmeno con l'oggetto stesso Per chiarire i loro reciproci rapporti
può essere forse utile la seguente similitudine.
Preso un
cannocchiale astronomico, esaminiamo il processo con cui, per mezzo di esso,
viene osservata la Luna. La Luna è l'oggetto di osservazione; questa
osservazione è resa possibile dall'immagine reale prodotta entro il
cannocchiale dall'obiettivo e dall'immagine retinica che si produce
nell'osservatore. Orbene: è facile cogliere una certa 381 analogia fra la Luna
e il significato, l'immagine prodotta dall'obiettivo e il senso, l'immagine
retinica e la rappresentazione o intuizione. E invero: mentre la Luna è
l'oggetto reale nella sua completezza, l'immagine prodotta dall'obiettivo è
soltanto unilaterale, poiché dipende dal punto di osservazione; malgrado ciò è
oggettiva, potendo servire a parecchi osservatori. La si può, in ogni caso,
accomodare in modo che molti si valgano di essa nel medesimo istante. Ciascuno
ha invece la sua propria immagine retinica. Persino una congruenza geometrica
fra le varie immagini retiniche sarebbe a stento raggiungibile, a causa della
diversa conformazione degli occhi; una coincidenza effettiva di esse resta poi
comunque esclusa.
Si potrebbe
forse continuare in questa similitudine ammettendo che l'immagine retinica del
soggetto A possa venir resa visibile al soggetto B o anche ad A stesso (per
mezzo di uno specchio). Questo servirebbe a spiegare come una rappresentazione
possa venir assunta essa stessa quale oggetto, e come però risulti diversa per
chi la osserva in questo modo e per chi invece se ne vale come propria
rappresentazione. Ma lo sviluppo di un tal parallelismo ci condurrebbe troppo
lontano dal nostro tema.
4. Quando si coglie una distinzione
tra parole, o tra espressioni, o tra intere proposizioni, possiamo riconoscere
che esistono tre gradi di differenza. La differenza può infatti riguardare: o
soltanto le rappresentazioni, o il senso ma non il significato, o infine anche
il significato.
Relativamente
alla differenze del primo tipo, bisogna osservare che, a causa del collegamento
incerto fra rappresentazione è parola, può sussistere una diversità per un
individuo là dove un altro non riesce affatto a vederla. Le differenze fra una
traduzione e il testo originale che le corrisponde dovrebbero non oltrepassare
questo primo gradino. Altri esempi di differenze che rientrano in esso, sono le
coloriture e i toni che l'arte poetica e l'eloquenza cercano di procurare al
senso dei nostri discorsi. Queste sfumature non sono qualcosa di oggettivo, ma
ogni uditore o lettore deve procurarsele egli stesso secondo i cenni del poeta
o dell'oratore. Senza dubbio l'arte non sarebbe possibile se non vi fosse una
certa affinità fra le rappresentazioni dei diversi uomini; 382 ma quanto si
corrisponda alle intenzioni del poeta, non è cosa che possa venir verificata
esattamente.
Nel seguito
del presente studio non parlerò più di rappresentazioni e intuizioni; esse sono
state qui menzionate soltanto allo scopo di non confondere il senso o il
significato di una parola con la rappresentazione che essa produce
nell'ascoltatore. Per riuscire a esprimerci con brevità e precisione,
converremo d'ora in poi di usare ordinariamente le seguenti locuzioni: useremo
il verbo esprimere riferendoci al senso di un nome proprio (parola, segno,
nesso di segni, espressione), e invece il verbo significare o denotare
riferendoci al suo significato. Diremo dunque: un segno esprime questo o
quel senso, denota questo o quel significato.
Ma forse
qualcuno - partendo da un punto di vista idealistico o scettico - vuole già da
un po' di tempo muovermi la seguente obiezione: Tu parli senz'altro della Luna
come se fosse un oggetto effettivo; ma da dove sai tu che il nome Luna abbia
davvero un significato? da dove sai che qualche segno abbia in generale un
significato?
Rispondo
senza difficoltà, osservando che certamente non è intenzione di alcuno di noi -
allorché parliamo della Luna - riferirci soltanto alla rappresentazione che noi
abbiamo di essa; anzi non possiamo nemmeno accontentarci di fare soltanto
riferimento al senso del termine Luna; di fatto noi tutti presupponiamo che
tale termine abbia un suo significato. È indubitabile, per esempio, che non
coglierebbe il senso della proposizione La Luna è più piccola della Terra chi
volesse pensare, che tale proposizione parla soltanto di una rappresentazione
della Luna. È certamente possibile che, con la proposizione anzidetta,
commettiamo un errore; ciò si è verificato non poche volte in casi analoghi. Ma
qui il non si tratta di rispondere al problema se ci sbagliamo sempre o no; si
tratta invece di vedere se è in generale giustificabile il parlare del
significato di un segno, per quanto - beninteso - con la riserva nel caso che
questo significato esista. Orbene: io sostengo che, per convincerci che un tale
asserto è giustificabile, basta dirigere l'attenzione su quello che è il nostro
effettivo intento allorché parliamo o pensiamo.
5. ▲Finora abbiamo trattato soltanto
del senso e del significato di quei segni (parole, espressioni) che chiamammo nomi
propri. ▼Ora ci 383 poniamo invece questo nuovo problema: che cosa sono il
senso e il significato di una intera proposizione assertoria? Una
proposizione siffatta contiene, com'è noto, un pensiero;8
bisognerà quindi stabilire innanzi tutto se questo pensiero debba venir
considerato come senso o come significato della relativa proposizione. A tale
scopo cominciamo a supporre che la proposizione abbia un significato, e
sostituiamo in essa, al posto di una parola, un'altra con lo stesso significato
ma con senso diverso; questa sostituzione non può certo influire sul
significato della proposizione. Orbene: che è accaduto, invece, del pensiero,
contenuto nella proposizione? Si vede subito che esso è modificato. (Per
esempio, il pensiero della proposizione La stella del mattino è un corpo
illuminato dal Sole risulta diverso dal pensiero della proposizione La stella
della sera è un corpo illuminato dal Sole. Tant'è vero che un individuo il
quale non sapesse che la stella del mattino coincide con quella della sera,
potrebbe ritenere vero il pensiero della prima e falso quello della seconda.)
Dunque il pensiero di una proposizione non può costituire il suo significato;
piuttosto dovremo vedere in esso il senso della proposizione considerata.
Ma che cosa
sarà allora il suo significato? E anzi; abbiamo il diritto di porre questa
domanda, oppure dobbiamo invece ammettere che una proposizione, intesa come un
tutto unico, può possedere un senso ma non mai un significato? Qualunque sia la
nostra risposta, c'è da attendersi senza dubbio che - analogamente ai nomi -
esistano anche delle proposizioni fornite di senso ma non di significato. Tali
saranno per esempio le proposizioni che contengono un nome proprio privo di
significato. Così l'asserto Ulisse fu sbarcato in Itaca mentre dormiva
profondamente ha palesemente un senso, ma è dubbio che abbia un significato,
perché è dubbio che ne abbia uno il termine Ulisse che fa parte della
proposizione. Comunque è certo che, se qualcuno ritiene seriamente vera o falsa
la proposizione, egli ammetterà che il nome Ulisse abbia, non solo un senso, ma
proprio un significato; è infatti al significato di questo nome che egli
attribuisce o non attribuisce il predicato cui fa cenno la proposizione. Chi
non ammette l'esistenza di tale significato, non può 384 attribuirgli o
negargli alcunché. Se invece qualcuno vuole fermarsi al pensiero della
proposizione anzidetta, sarà per lui superfluo indagare circa il significato
delle parti che la costituiscono; per il senso di una proposizione può infatti
interessare soltanto il senso delle sue parti. Che il nome Ulisse abbia o no un
significato, non muta il pensiero contenuto nell'asserto di poco fa. Se noi ci
preoccupiamo del significato di qualche parte di una proposizione, questo prova
che riconosciamo, e anzi esigiamo, in generale, un significato per l'intera
proposizione.
Il pensiero
contenuto in una proposizione perde subito una parte del suo valore, se
constatiamo che una sua parte manca di significato. È dunque molto giusto che
non ci accontentiamo del senso di una proposizione ma ne cerchiamo il
significato. Per quale motivo vogliamo che ogni nome proprio possegga, non
soltanto un senso, ma anche un significato? Per qual motivo non ci basta il
pensiero? Perché ciò che ci interessa è il valore di verità delle nostre
proposizioni; se viene a mancare quest'interesse preminente per la verità,
cessa senz'altro quell'insufficienza del pensiero. E ciò si verifica in alcuni
casi; per esempio, quando ascoltiamo la lettura di un componimento epico, noi
siamo esclusivamente attratti, oltre che dalle melodie della lingua, dal senso
delle proposizioni e dalle immagini e dai sentimenti da esse suscitate in noi.
Con il problema della verità noi perderemmo la gioia artistica e trasformeremmo
la poesia in una ricerca scientifica. Perciò, fin quando rimaniamo nel campo
dell'arte, poco ci importa se il nome Ulisse abbia o no un significato.9
Ciò che ci
fa avanzare dal senso al significato è la ricerca della verità.
Si è visto
che dobbiamo cercare un significato per una proposizione, ogniqualvolta ci
interessiamo del significato delle sue singole parti; e questo accade quando, e
soltanto quando, sorge in noi il problema del suo valore di verità. Eccoci
dunque indotti a vedere il significato di una proposizione nel suo valore di
verità. Per valore di verità di una proposizione, io intendo la circostanza che
essa sia vera o falsa. Altri valori di verità, 385 oltre questi due, non ve ne
sono; per semplicità essi verranno chiamati senz'altro il Vero e il Falso 10.
Ogni
proposizione assertoria (in cui, come si è visto, ciò che interessa è il
significato delle sue parole) va dunque riguardata come un nome proprio; e il
suo significato - posto che ve ne sia uno - dovrà essere o il Vero o il Falso.
Chiunque pronunci giudizi, chiunque ritenga qualcosa come vera, anche lo stesso
scettico, deve - sia pure solo tacitamente - riconoscere questi due oggetti.
L'attribuire
il nome di oggetti ai due valori di verità può forse sembrare un'idea
arbitraria, un puro gioco di parole da cui è impossibile dedurre alcuna
conseguenza profonda. Per giustificarmi, dovrei discutere con precisione che
cosa io intenda per oggetto, analizzandone i rapporti con il concetto e con la
relazione; questo mi porterebbe però troppo fuori dal tema in esame. Mi basterà
dunque aver stabilito qui chiaramente che in ogni giudizio,11
sia pur semplicissimo, vi è già un trapasso dal grado del puro e semplice
pensiero al grado del significato (cioè dell'oggettivo). Forse ci si potrebbe
sentir tentati di credere che il pensiero ed il vero non stiano fra loro nel
rapporto di senso e significato, ma nel rapporto di soggetto e predicato. Anzi,
per meglio accentuare la cosa, qualcuno vorrà forse dire: Il pensiero che 5 sia
un numero primo è vero invece di affermare semplicemente 5 è un numero primo.
Ma chi analizzi un po' da vicino la cosa, vede senza difficoltà che la prima di
queste due proposizioni non afferma nulla più della seconda. L'asserzione della
verità risiede, in entrambi i casi, nella forma della proposizione assertoria;
e pertanto, dove questa proposizione non possegga la sua forza abituale - per
esempio sulla bocca di un attore sulla scena - lo stesso primo asserto (Il
pensiero che 5 sia un numero primo è vero) enuncerà nulla più che un pensiero,
e precisamente 386 l'identico pensiero contenuto nella seconda proposizione (5
è un numero primo). Da ciò si deve concludere che il rapporto fra il pensiero e
il vero non può venir paragonato al rapporto fra soggetto e predicato.
Soggetto e
predicato, intesi in senso logico, sono parti del pensiero, e stanno sul
medesimo piano rispetto al conoscere. Collegandoli l'uno all'altro, si giunge
semplicemente a un pensiero, non si trapassa da un senso al suo significato, da
un pensiero al suo valore di verità. Ci si muove sempre sul medesimo gradino,
non si sale a quello superiore. Un valore di verità non può essere parte di un
pensiero, proprio come non lo può essere il Sole; esso non è un pensiero ma un
oggetto.
Se è giusta
la nostra ipotesi che il significato di una proposizione risieda nel suo valore
di verità, allora è chiaro che questo valore di verità dovrà rimanere immutato
sostituendo, a una parte della proposizione qualche nuova proposizione con lo
stesso significato ma con senso diverso. E di fatto avviene proprio così.
Leibniz spiega per l'appunto: eadem sunt, quae sibi mutuo substitui possunt,
salva veritate. Orbene: che altro potremmo trovare, oltre il valore di verità,
che spetti proprio a tutte le proposizioni, tenga conto del significato delle
parti costitutive di esse, e non vari nelle sostituzioni del tipo anzidetto?
Se il
significato di una proposizione è costituito dal suo valore di verità, se ne
conclude che, per un lato, tutte le proposizioni vere avranno lo stesso
significato, e così per l'altro tutte quelle false. Dunque, nel significato di
una proposizione scompare ciò che v'è in essa di particolare. Ne segue che
l'importante, per una proposizione, non potrà mai essere il suo solo
significato. Ma d'altra parte, nemmeno il puro pensiero produce qualche
conoscenza; ciò che la produce è il pensiero insieme con il suo significato,
ossia con il suo valore di verità.
Possiamo
dunque concepire il giudicare come un sollevarsi da un pensiero al suo valore
di verità. Questa però non deve costituirne una definizione. Il giudicare è in
realtà una cosa assolutamente singolare e inconfondibile con ogni altra. Si
potrebbe anche dire che il giudicare sia un distinguere le parti entro il
valore di verità. Questo distinguere si realizza con un ritorno al pensiero:
ogni senso che appartiene a valore di verità, corrisponderebbe a uno speciale
modo di compiere tale distinzione. 387
Con ciò uso
evidentemente la parola parte in un modo diverso dal comune; e cioè trasferisco
il rapporto fra parte e tutto dalla proposizione al suo significato, in quanto
chiamo parte del significato di una proposizione il significato delle parole
che la compongono. Senza dubbio questa è una locuzione assai discutibile, sia perché,
nel significato, il tutto e una parte non determinano la parte residua, sia
perché nei corpi la parola parte viene usata in un senso diverso. Per la nostra
idea bisognerebbe coniare un'espressione nuova e adatta al caso speciale.
6. Dobbiamo ora riprendere l'esame
della supposizione poco fa esposta, che il significato di una proposizione sia
costituito per intero dal suo valore di verità.
Già abbiamo
trovato che questo valore rimane intatto quando nella proposizione in esame si
sostituisce un'espressione con qualche altra avente lo stesso significato; non
abbiamo ancora però considerato il caso che l'espressione da sostituire sia
essa stessa una proposizione.
Se la nostra
teoria è giusta, il valore di verità di una proposizione composta dovrà
rimanere immutato, allorché sostituiamo in essa, al posto di una sua
proposizione parziale, qualche altra avente lo stesso valore di verità. Dovremo
però attenderci eccezioni quando la proposizione composta o quella parziale
siano discorsi diretti o indiretti; in questi casi infatti, come già si è
visto, il significato delle parole non è quello ordinario. (Nel discorso
diretto, il significato di una proposizione è di nuovo una proposizione; in
quello indiretto è un pensiero.)
Ci troviamo
così condotti alla discussione delle proposizioni secondarie. Esse
costituiscono le parti di un periodo; e questo periodo si presenta, dal punto
di vista logico, come una proposizione (precisamente, come la proposizione
principale). Qui sorge subito il problema, se anche il significato delle
proposizioni secondarie sia, come quello delle primarie, un valore di verità.
La risposta sarà, almeno parzialmente, negativa perché sappiamo che il
significato del discorso indiretto non è un valore di verità.
I grammatici
considerano le proposizioni secondarie come puri surrogati di parti di
proposizioni, e le suddividono quindi in nominali, 388 esplicative e
avverbiali. Questo ci può far venire il sospetto che il significato di una
proposizione secondaria non sia costituito di un valore di verità, ma risulti
dello stesso genere del significato di un nome, di un aggettivo o di un
avverbio (cioè di una parte di proposizione il cui senso non è un pensiero ma
una parte di esso). Soltanto una ricerca più precisa ci potrà chiarire la cosa.
In tale ricerca non dovremo seguire fedelmente il filo conduttore della
grammatica, ma dovremo raggruppare ciò che è logicamente omogeneo.
Cominciamo a
prendere in esame quei casi nei quali, come appunto sospettavamo, il senso di
una proposizione secondaria risulta non essere un pensiero indipendente. Fra le
proposizioni nominali astratte, introdotte nel periodo per mezzo di un
"che", vanno annoverate le proposizioni indirette; e si è già visto
che le singole parole di queste hanno un significato indiretto, cioè un significato
che coincide con il senso ordinario. In questo caso, dunque, il significato
della proposizione secondaria non può essere un valore di verità, ma un
pensiero; il suo senso invece non sarà (come per le proposizioni principali) un
pensiero, ma sarà il senso delle seguenti parole il pensiero che... (ed esso
costituisce soltanto una parte del pensiero dell'intero periodo). Ciò avviene
dopo i verbi dire, udire, pensare, essere persuaso, concludere, e analoghi 12. Diversamente, e per vero in modo assai
complicato, stanno le cose dopo certi verbi come riconoscere, sapere, credere.
Ma su questi ultimi ritorneremo più tardi.
Che nei casi
anzidetti il significato della proposizione secondaria sia proprio un pensiero,
risulta anche dal fatto che è indifferente per la verità del periodo
complessivo se quel pensiero sia vero o falso. Si confrontino per esempio le
due proposizioni Copernico credeva che le traiettorie dei pianeti fossero
cerchi e Copernico credeva che il moto apparente del Sole fosse prodotto dal
moto reale della Terra. Qui si può scambiare una proposizione secondaria con
l'altra, senza compromettere il valore di verità dell'intero periodo.13 Questo periodo, malgrado 389 grado sia
composto di una proposizione principale e di una secondaria, ha come senso un
unico pensiero, e la sua verità non include né esclude quella della
proposizione secondaria.
In casi come
quello ora considerato, è permesso - nella proposizione secondaria - sostituire
un'espressione qualsiasi con un'altra, non se quest'altra ha lo stesso
significato ordinario della prima, ma solo se ha lo stesso significato
indiretto (cioè lo stesso senso ordinario). Se però qualcuno ne volesse
concludere che il significato di una proposizione non è il suo valore di verità
perché, se così fosse, dovrebbe esser lecito sostituirla, in qualunque luogo
essa compaia, con un'altra proposizione avente lo stesso valore di verità, egli
andrebbe con ciò molto al di là del giusto; con lo stesso diritto si potrebbe
asserire che il significato della parola Venere è diverso da quello
dell'espressione stella del mattino, perché non in ogni caso è lecito usare
l'una espressione per l'altra. Ciò che si può rettamente concludere è soltanto
questo: il significato di una proposizione non coincide sempre con il suo
valore di verità, così come il significato dell'espressione stella del mattino
non è sempre costituito dal pianeta Venere (per esempio quando l'espressione
stella del mattino viene usata nel discorso indiretto). Questo caso eccezionale
per il significato delle proposizioni si presenta, per l'appunto, allorché
abbiamo a che fare con proposizioni secondarie sui tipo di quelle ora prese in
esame: il loro significato infatti è un pensiero.
Se un
individuo dice sembra che ... egli pensa in realtà mi sembra che ..., ovvero io
penso che .... Abbiamo dunque, di nuovo, in queste proposizioni, il caso
eccezionale predetto. Le cose vanno in modo analogo per le proposizioni del
tipo rallegrarsi, deplorare, approvare, biasimare, sperare, temere, ecc. Se,
verso la fine della battaglia di Belle-Alliance, Wellington si rallegrò per il
prossimo arrivo dei prussiani, il motivo della sua gioia fu soltanto una
persuasione. Anche se si fosse ingannato, non perciò sarebbe stato meno lieto,
finché perdurava la sua illusione; e invece, prima di essersi persuaso del loro
arrivo, non poteva rallegrarsene, per quanto essi di fatto già si
avvicinassero.
Come una
persuasione o una fede costituisce, assai spesso, la base di un sentimento,
così può anche - in certi casi - costituire la base 390 di un'altra persuasione
(questo avviene, per esempio, nei ragionamenti). Nella proposizione Dalla
rotondità della Terra Colombo concluse di poter raggiungere le Indie navigando
verso occidente abbiamo, come significato delle sue parti, due pensieri: che la
Terra sia rotonda, e che Colombo possa raggiungere le Indie navigando verso
occidente. L'importante è qui, di nuovo, soltanto questo: che Colombo era
persuaso dell'una cosa come dell'altra, e che la prima persuasione costituiva
il fondamento della seconda. Se poi la Terra risulti proprio rotonda o no, e se
Colombo potesse davvero - come pensava - raggiungere l'India navigando verso
ovest, è indifferente per la verità dell'asserto considerato. Questa verità
sarebbe invece alterata se, in luogo del termine Terra, si sostituisse
quest'altra espressione Il pianeta che è accompagnato da un satellite con
diametro maggiore del quarto di quello del pianeta stesso 14. Anche nel presente caso abbiamo dunque a che
fare con il significato indiretto delle parole. Le proposizioni finali
appartengono esse pure al medesimo tipo; il fine infatti è, evidentemente, un
pensiero. Anche in esse dunque avremo significato indiretto delle parole e
congiuntivo.
Le proposizioni
rette dai verbi ordinare, pregare, proibire avrebbero, nel discorso diretto, la
forma di imperativi. Esse non hanno alcun significato ma soltanto un senso. Un
ordine, una preghiera, non sono a rigore dei pensieri; stanno però sullo stesso
piano dei pensieri. Perciò le parole hanno, in tali proposizioni, il loro
significato indiretto. Il significato di queste proposizioni non è dunque un
valore di verità, ma un ordine, una preghiera, ecc. Lo stesso può ripetersi per
le proposizioni che dipendono dai verbi dubitare se, non sapere se, e analoghi.
È facile infatti vedere che anche in esse le parole vanno prese nel loro
significato indiretto. Le proposizioni interrogative, che iniziano con le
parole dove, quando, chi, che cosa, come, per mezzo di che, ecc. sembrano
talora approssimarsi molto a proposizioni avverbiali, nelle quali le parole
hanno il loro significato comune. Linguisticamente, i due casi si distinguono
per il modo del verbo. Il congiuntivo si usa nelle proposizioni 391 dipendenti,
nelle quali le parole hanno significato indiretto, nelle quali cioè un nome
proprio non può generalmente venir sostituito con un altro denotante il
medesimo oggetto.
7. Nei casi finora presi in esame, le
parole avevano, nelle proposizioni secondarie, il loro significato indiretto, e
da ciò derivava che tali proposizioni avevano esse pure un significato
indiretto; cioè, non un valore di verità, ma un pensiero, un ordine, una
preghiera, una domanda. La proposizione secondaria poteva venire interpretata -
in questi casi - come un sostantivo, anzi, si potrebbe dire, come il nome
proprio di quel pensiero, di quell'ordine, ecc., per denotare il quale essa
veniva introdotta nel complesso del periodo.15
Passiamo ora
invece ad altre proposizioni secondarie, le quali usano - senza alcun dubbio -
le parole nel loro significato ordinario e ciò malgrado non hanno, come senso,
un pensiero, né hanno come significato un valore di verità. Come ciò sia
possibile, ce lo chiarirà nel miglior modo un esempio:
Chi scoperse la forma ellittica
delle traiettorie dei pianeti, morì in miseria.
Se la
proposizione secondaria avesse qui come senso un vero e proprio pensiero (cioè
un pensiero completo), dovrebbe risultare possibile esprimere lo stesso
pensiero anche per mezzo di una proposizione principale. Ciò però è
impossibile, dato che il soggetto grammaticale chi non possiede un senso
indipendente ma ha la funzione precipua di stabilire un rapporto con la
proposizione seguente morì in miseria. Dunque, il senso della proposizione
secondaria ora considerata è esso pure un pensiero non completo, e il suo
significato non è un valore di verità ma è Keplero.16
Contro
questa conclusione taluno potrebbe obiettare che il senso dell'intero periodo
include però, come parte, il pensiero che vi fu una 392 persona che riconobbe,
per prima, la forma ellittica delle traiettorie dei pianeti; non può infatti
ritenere per vero l'intero periodo chi neghi questa sua parte. Ciò è fuori
dubbio; ma soltanto perché, in caso contrario, la proposizione Chi scoperse la
forma ellittica di quelle traiettorie risulterebbe priva di significato. In
qualsiasi asserto è sempre implicita l'ipotesi che i nomi propri usati (siano
essi termini semplici o espressioni composte) posseggano un qualche
significato. Se per esempio si afferma Keplero morì in miseria, si presuppone
ovviamente che il nome Keplero denoti qualcuno. Non ne segue tuttavia che il
senso della proposizione Keplero morì in miseria contenga in sé il pensiero Il
nome Keplero denota qualcuno. Ce lo prova il fatto che, se così fosse, la
negazione della proposizione suddetta non dovrebbe suonare (come effettivamente
suona) Keplero non mori in miseria, bensì
Keplero non morì in miseria, oppure il nome Keplero è privo di significato. La realtà è invece questa: il fatto che il nome Keplero denoti qualcuno, costituisce un presupposto tanto per l'asserto Keplero morì in miseria quando per l'asserto contrario.
Keplero non morì in miseria, oppure il nome Keplero è privo di significato. La realtà è invece questa: il fatto che il nome Keplero denoti qualcuno, costituisce un presupposto tanto per l'asserto Keplero morì in miseria quando per l'asserto contrario.
Le lingue
hanno generalmente il difetto di rendere possibili espressioni che per la loro
forma grammaticale sembrano determinate, e cioè sembrano denotare un oggetto,
mentre in alcuni casi questa loro determinatezza non è effettiva, dipendendo
dalla verità di un'altra proposizione. Così dipende dalla verità dell'asserto
Vi fu un individuo, che scoperse la forma ellittica delle traiettorie dei pianeti,
se la proposizione Chi scoperse la forma ecc. denoti realmente qualcuno, o
invece sembri soltanto denotarlo e risulti priva di significato. È,
analogamente, illusorio pensare che la nostra proposizione contenga, come parte
del suo senso, il pensiero Vi fu uno che scoperse la forma ellittica delle
traiettorie dei pianeti. Se essa contenesse davvero questo pensiero, la sua
negazione dovrebbe venir enunciata così: Chi scoperse per primo la forma
ellittica delle traiettorie dei pianeti non mori in miseria, oppure non vi fu
nessuno che scoperse la forma ellittica d itali traiettorie. 393 Questa
illusione è dunque dovuta, come abbiamo visto, a una incompletezza della lingua
ordinaria 17.
Va però
notato che neanche la lingua concettuale matematica è immune da tale
incompletezza; pure in essa, infatti, possono comparire complessi di segni che
sembrano significare qualcosa, mentre - almeno finora - risultano di fatto
privi di ogni significato. Tale, per esempio, l'espressione successione
infinita divergente. Si può evitare questa lacuna della lingua matematica,
aggiungendo qualche convenzione speciale; per esempio, stabilendo che tutte le
successioni infinite divergenti abbiano per significato lo zero.
Affinché una
lingua (ideografia) risulti logicamente completa, si deve pretendere:
- che ogni sua espressione che risulti costituita nella forma di nome proprio, a partire da segni già noti e secondo regole grammaticali esatte, denoti anche di fatto un oggetto;
- che non venga introdotto in essa alcun nuovo segno come nome proprio, senza che gli sia assicurato un preciso significato.
I logici
sogliono mettere in guardia contro le parole che hanno molti significati,
considerandole come fonti di gravissimi errori. Io ritengo non meno giusto
mettere in guardia contro i nomi propri apparenti, che non sono forniti di
alcun significato. Altri esempi (oltre quelli or ora accennati) del medesimo
errore ci possono venire forniti dall'abuso di parole fatto nei discorsi
demagogici. Così sarebbe facile constatare che l'espressione la volontà del
popolo non denota alcun significato preciso, almeno generalmente riconosciuto.
È dunque
senza dubbio importante eliminare una volta per sempre, almeno dal linguaggio
scientifico, la fonte di questi errori. Una volta compiuta questa eliminazione,
diventeranno impossibili le obiezioni sul tipo di quelle sopra discusse, perché
non potrà più dipendere dalla verità di un pensiero se un certo nome proprio
abbia o no un significato. 394
8. Nella
nostra trattazione possiamo collegare alle proposizioni ora esaminate un tipo
di proposizioni esplicative e avverbiali che logicamente sono molto affini a
esse. Anche le proposizioni esplicative servono a formare nomi propri composti,
pur non bastando da sole a questo scopo come vi bastano invece le proposizioni
nominali. Esse vanno ritenute analoghe agli aggettivi. Per esempio, invece di
dire la radice quadrata di 4 che è minore di zero possiamo dire la radice
quadrata negativa di 4. Abbiamo qui il caso in cui da un nome di concetto si
ottiene un nome proprio composto, introducendo l'articolo determinativo usato
al numero singolare. Ciò è lecito ogniqualvolta sotto quel concetto cada uno e
un solo oggetto.18 Ora certi nomi di concetti possono risultare
costituiti in modo che le loro note caratteristiche vengono proprio enunciate
per mezzo di proposizioni esplicative; così accade nell'esempio di poco fa, in
cui la nota è espressa dalla proposizione che è minore di zero. Risulta chiaro
che proposizioni esplicative siffatte non possono avere come senso un pensiero
né come significato un valore di verità, proprio alla stessa stregua delle
proposizioni nominali poco fa esaminate.
Il senso di
una tale proposizione esplicativa sarà costituito soltanto da una parte di un
pensiero, parte che in taluni casi può venire espressa anche per mezzo di un
unico aggettivo. Qui pure, come per le proposizioni esaminate nelle pagine
addietro, manca un soggetto indipendente, e quindi manca la possibilità di
tradurre il senso della proposizione esplicativa (secondaria) in una
proposizione principale a sé stante.
Spazi,
istanti, intervalli sono - considerati da un punto di vista logico - oggetti;
quindi l'indicazione linguistica di un determinato luogo o di un determinato
istante o intervallo di tempo va considerata come un nome proprio. Orbene, per
coniare tale nome proprio, possono venir usate proposizioni avverbiali di tempo
o di luogo in modo analogo a quello sopra esaminato per le proposizioni
nominali ed esplicative. Proprio così si riescono ad esprimere concetti che abbracciano
in sé 395 luoghi, tempi, ecc. Anche per queste proposizioni secondarie va
osservato che il loro senso non può venir reso per mezzo di una proposizione
principale; quest'ultima infatti non può contenere una parte che per esse è
essenziale, cioè la specificazione dello spazio o del tempo (tale
specificazione può venire indicata soltanto con un pronome relativo o con una
congiunzione)19.
Anche nelle
proposizioni condizionali, analogamente a quello che abbiamo visto per le
proposizioni nominali, esplicative, avverbiali, è contenuto il più delle volte
un termine di significato non preciso, cui ne corrisponde uno similmente
impreciso nella proposizione che esprime la tesi. Poiché questi due termini si
riferiscono l'uno all'altro, essi collegano le due proposizioni (quella che
esprime l'ipotesi e quella che esprime la tesi) in un tutto unico, che esprime
in genere un solo pensiero. Nella proposizione Se un numero è minore di 1 e
maggiore di 0, anche il suo quadrato è minore di 1 e maggiore di 0, questi due
termini sono: nell'ipotesi un numero e nella tesi il suo. Per l'appunto questa
imprecisione procura al senso della frase la generalità che ci si attende da
una legge. Proprio essa però dimostra che la proposizione condizionale - da
sola - non possiede come senso alcun pensiero completo. L'ipotesi esprime un
pensiero solo unitamente alla tesi, e precisamente un pensiero unico, le cui
parti non sono più pensieri. 396
È in
generale inesatto affermare che in un giudizio ipotetico vengano posti in
correlazione reciproca due giudizi diversi. Quando si asserisce questo o
qualcosa di simile, si usa evidentemente la parola giudizio nel medesimo senso
che io ho attribuito alla parola pensiero20, sicché la stessa affermazione potrebbe venir
enunciata dicendo In un pensiero ipotetico vengono posti in correlazione due
pensieri diversi. Orbene, ciò potrebbe esser vero, soltanto se l'ipotesi e la
tesi non contenessero un termine di significato impreciso 21; allora però verrebbe a mancare anche la loro
generalità.
Se,
nell'ipotesi e nella tesi, si deve accennare in modo indeterminato a un
istante, lo si fa non di rado unicamente con il tempus praesens del verbo, che
in questo caso non indica il momento presente. Questa forma grammaticale è,
allora, sia nella proposizione principale sia nella secondaria, la parte che
non ha significato preciso. Ecco un esempio: Se il sole attraversa il tropico
del Cancro, abbiamo nell'emisfero nord della Terra il giorno di durata massima.
Anche qui è
impossibile esprimere il senso della proposizione secondaria per mezzo di una
proposizione principale, poiché esso non è un pensiero completo. Se infatti
dicessimo: Il Sole attraversa il tropico del Cancro, noi riferiremmo questo
fatto all'istante presente, e quindi muteremmo il senso della proposizione.
Altrettanto può ripetersi per il senso della proposizione principale (tesi).
Solo il tutto, costituito dalla proposizione principale e dalla secondaria,
contiene un pensiero. In altri casi possono avere un significato indeterminato
più termini comuni all'ipotesi e alla tesi. È evidente che proposizioni
nominali, formate con i termini chi, che cosa, e proposizioni avverbiali
formate con i termini dove, quando, sempre dove, sempre che, vanno spesso
interpretate come proposizioni condizionali; cosi accade per esempio nel
proverbio Chi tocca il vischio vi resta impaniato. 397 Anche proposizioni
esplicative possono tenere il posto di proposizioni condizionali.
Ciò accade
per esempio quando enunciamo l'asserto esaminato alcune pagine addietro in
questa nuova forma: Il quadrato di un numero, che sia maggiore di 0 o minore di
1, è maggiore di 0 e minore di 1.
9. Le cose vanno in tutt'altro modo,
se l'elemento comune alla proposizione principale e alla secondaria è
rappresentato da un nome proprio. Esaminiamo per esempio l'affermazione:
Napoleone, che si accorse del pericolo per il suo fianco destro, guidò egli
stesso la sua Guardia contro la posizione nemica.
In essa sono
espressi due pensieri:
- Napoleone riconobbe il pericolo per il suo fianco destro;
- Napoleone guidò egli stesso la sua Guardia contro la posizione nemica.
Quando e
dove ciò avvenne può certamente venir appreso soltanto dal contesto generale
del periodo; deve tuttavia riguardarsi come determinato da tale contesto.
Affermando l'intera nostra proposizione, noi affermiamo con ciò in un contempo
le due parti che la costituiscono. Se una di esse è falsa, è falso di
conseguenza il tutto. Abbiamo qui il caso, in cui già il senso della sola proposizione
secondaria è un pensiero completo (supposto, naturalmente, che lo completiamo
con un'indicazione di tempo e di luogo). Il significato di tale proposizione
secondaria sarà perciò un valore di verità. Possiamo dunque attenderci che la
proposizione secondaria possa venir sostituita, senza pregiudizio per la verità
del tutto, da un'altra proposizione avente lo stesso valore di verità. E cosI
accade infatti nel nostro caso: si deve soltanto badare che il soggetto della
nuova proposizione sia ancora Napoleone. Ciò per motivi puramente grammaticali;
ossia perché solo in tal modo essa può venir usata nella forma di proposizione
esplicativa del termine Napoleone. Ma se si prescinde da quest'ultima esigenza
- ammettendo per esempio che le due proposizioni possano venir collegate da un
e - allora cade pure la condizione anzidetta.
Anche nelle
proposizioni secondarie, che hanno inizio con il termine 398 sebbene, si
trovano espressi pensieri completi. Questa congiunzione non ha, a rigor di
termini, alcun suo senso specifico, né muta il senso della proposizione cui
viene preposta, ma lo illumina in una maniera particolare 22. E invero potremmo, senza pregiudizio della
verità del tutto, sostituire un asserto, esprimente qualche concessione, con un
altro asserto provvisto dello stesso valore di verità; sorgerebbe allora
quest'unico inconveniente: che la proposizione si troverebbe probabilmente in
una luce fuori posto, come si volesse intonare su di un motivo allegro un canto
di contenuto triste.
Negli ultimi
casi citati la verità del tutto includeva quella delle parti. Non cosi accade
quando una proposizione condizionale esprime un pensiero completo, contenendo un
nome proprio, o qualcosa che gli si debba considerare equivalente, invece del
termine esclusivamente indicativo.
Si consideri
per esempio la proposizione: Se in questo momento si è già levato il Sole, il
cielo è fortemente nuvoloso.In essa il tempo è rappresentato dal momento
presente, e quindi è perfettamente determinato. Anche il luogo deve
considerarsi come determinato. Si può dire che essa pone una relazione precisa
tra i valori di verità dell'ipotesi e quelli della tesi; e precisamente che è
impossibile sia vera la prima e falsa la seconda. Se ne conclude che la nostra
proposizione è vera, tanto se il Sole nel momento presente non è ancora sorto,
quanto se è sorto e il cielo è fortemente nuvoloso.
Poiché qui
interessano soltanto i valori di verità, risulta possibile sostituire ognuna
delle proposizioni parziali con un'altra, avente lo stesso valore di verità,
senza alterare con ciò la verità del tutto. È certo che anche in questo caso
una sostituzione siffatta porrebbe, il più delle volte, l'asserto in una luce
impropria, e ne risulterebbe un pensiero probabilmente insulso. Ma questo non
ha nulla a che vedere con il valore di verità della proposizione considerata.23 Bisogna sempre tener presente 399 che i nostri
asserti suscitano in noi dei secondi pensieri, i quali però non sono
effettivamente espressi e quindi non possono venir compresi nel senso delle
proposizioni; non si può dunque attribuire importanza al loro valore di verità 24.
10. Con ciò possono dirsi discussi i
casi più semplici. Diamo ora uno sguardo retrospettivo ai risultati della
nostra ricerca. La proposizione secondaria ha il più delle volte come senso non
un pensiero, ma soltanto una parte di esso, e quindi non ha per significato un
valore di verità. Questo trova la sua spiegazione o nel fatto che le parole
della proposizione secondaria hanno il loro senso indiretto, sicché il
significato (e non il senso) della proposizione stessa è costituito da un
pensiero; o nel fatto che la proposizione secondaria è incompleta perché un suo
termine possiede soltanto un significato indeterminato, sicché essa può
esprimere un pensiero solo unitamente alla proposizione principale.
Si danno
però anche dei casi nei quali il senso della proposizione secondaria risulta un
pensiero completo, e allora essa può venir sostituita, senza pregiudizio della
verità del tutto, da un'altra proposizione avente lo stesso valore di verità
(nei limiti in cui non vi si oppongano impedimenti di carattere grammaticale).
Se dopo di
ciò esaminiamo tutte le proposizioni secondarie possibili, se ne incontrerà
subito qualcuna che non si lascia inquadrare nella nostra classificazione. Il
motivo risiede, a mio parere, nel fatto che essa non avrà un senso semplice.
È chiaro che
noi colleghiamo quasi sempre a un pensiero principale, espresso, alcuni
pensieri secondari che, sebbene non espressi, il nostro interlocutore connette
alle nostre parole secondo leggi psicologiche. E poiché essi sembrano
naturalmente collegati alle nostre parole quasi come il pensiero principale, ne
seguirà che noi intendiamo esprimere insieme con il pensiero principale anche
tali pensieri secondari.
Ciò
arricchisce il senso della proposizione, e può accadere che noi abbiamo 400 più
pensieri semplici che non proposizioni. In taluni casi la proposizione va
interpretata in questo modo, in altri risulta dubbio se il pensiero secondario
appartenga con quello principale al senso della proposizione, o se lo
accompagni soltanto 25. Si potrebbe forse ritenere che nella
proposizione: Napoleone, il quale si accorse del pericolo per il suo fianco
destro, guidò egli stesso la sua Guardia contro la posizione nemica, risultino
espressi non soltanto i due pensieri indicati dall'analisi di poco fa, ma anche
il pensiero che la percezione del pericolo fu il motivo per cui Napoleone guidò
la sua Guardia contro la posizione nemica. In realtà non è molto chiaro se
quest'ultimo pensiero sia soltanto suggerito o effettivamente espresso.
Per veder
bene la cosa, domandiamoci se la nostra proposizione risulterebbe falsa nel
caso che la decisione di Napoleone fosse già stata presa prima di accorgersi
dell'anzidetto pericolo. Qualora, malgrado quest'ipotesi, la nostra
proposizione fosse ancora vera, il pensiero secondario di cui sopra non
andrebbe concepito come parte costitutiva del senso della nostra proposizione.
Probabilmente ci si deciderà per questa interpretazione. Nel caso opposto, la
situazione si complicherebbe: noi avremmo allora come proposizioni più pensieri
semplici.
Se ora alla
proposizione Napoleone si accorse del pericolo per il suo fianco destro, ne
sostituiamo un'altra con il medesimo valore di verità, per esempio la seguente:
Napoleone aveva già più di 45 anni, veniamo a modificare non solo il primo ma
anche il terzo dei nostri pensieri, e potrebbe quindi riuscir alterato il
valore di verità di quest'ultimo (ciò accade di fatto se l'età di Napoleone non
influì nella sua decisione di guidare la propria Guardia contro il nemico). Si comprende
da ciò perché - in tali casi - non si possano sempre sostituire l'una all'altra
due proposizioni con lo stesso valore di verità. In essi infatti una
proposizione esprime, per trovarsi connessa con un'altra, più di quel che
esprime da sola.
Esaminiamo
dunque i casi, nei quali si verifica qualcosa di simile. 401 E, al solito,
rivolgiamo la nostra attenzione a un esempio concreto: Bebel si illude che,
colla restituzione dell'Alsazia-Lorena, possano venir placati i desideri di
vendetta della Francia. Qui si trovano espressi due pensieri, dei quali però
non è vero che l'uno appartenga alla proposizione principale e l'altro alla
secondaria. Essi sono:
- Bebel ritiene che, con la restituzione dell'Alsazia-Lorena, possano venir placati i desideri di vendetta della Francia;
- con la restituzione dell'Alsazia-Lorena non possono venir placati i desideri di vendetta della Francia.
Nell'espressione
del primo pensiero, le parole della proposizione secondaria hanno il loro
significato indiretto, mentre le stesse parole, nell'espressione del secondo
pensiero, hanno il loro significato usuale. Vediamo di qui che, nel nostro
periodo primitivo, la proposizione secondaria va considerata come l'insieme di
due proposizioni aventi significati diversi: uno dei quali è un pensiero,
l'altro un valore di verità. Orbene, dato che il valore di verità non
costituisce l'intero significato della proposizione secondaria, ne segue che
noi non possiamo sostituirla semplicemente con un'altra proposizione avente lo
stesso valore di verità.
Si ripete
una situazione analoga nelle espressioni come sapere, comprendere, è noto.
Anche con una proposizione causale e con la sua proposizione principale, noi
esprimiamo diversi pensieri, che però non corrispondono a uno a uno a quelle
proposizioni. Per esempio nella proposizione: Il ghiaccio galleggia sull'acqua
perché ha un peso specifico minore di essa sono espressi i seguenti pensieri:
- il ghiaccio ha un peso specifico minore dell'acqua;
- se qualcosa ha un peso specifico minore dell'acqua, galleggia su di essa;
- il ghiaccio galleggia sull'acqua.
II terzo
pensiero potrebbe non venire espresso, essendo contenuto nei due primi. Al
contrario, né il primo e il terzo insieme, né il secondo e il terzo, potrebbero
costituire da soli il senso della proposizione. È chiaro che nella nostra
proposizione secondaria Perché il ghiaccio 402 ha un peso specifico minore
dell'acqua viene espresso tanto il nostro primo pensiero quanto, in parte,
anche il secondo. Questo è il motivo per cui non possiamo sostituirla
semplicemente con un'altra che abbia lo stesso valore di verità; con una tale
sostituzione infatti si verrebbe pure a modificare il nostro secondo pensiero e
da ciò potrebbe risultare intaccato anche il valore di verità di esso.
Similmente
accade nella proposizione: Se il ferro avesse un peso specifico minore
dell'acqua, galleggerebbe su di essa.
Abbiamo qui
i due pensieri:
- che il ferro non possiede un peso specifico minore dell'acqua;
- che ciò che ha peso specifico minore dell'acqua galleggia su di essa.
La
proposizione secondaria esprime di nuovo un pensiero e una parte dell'altro. Se
nell'asserto poco sopra esaminato: Dopo che lo Schleswig-Holstein fu tolto
dalla Danimarca, Austria e Prussia entrarono in discordia fra loro vogliamo
vedere espresso anche il pensiero che lo Schleswig-Holstein venne, una volta,
tolto alla Danimarca, allora troviamo in tale asserto due pensieri:
- in primo luogo quello ora accennato;
- in secondo luogo il pensiero che Austria e Prussia vennero in discordia fra loro in un tempo più particolarmente determinato dalla proposizione secondaria.
Anche qui,
allora, la proposizione secondaria esprime non soltanto un pensiero, ma anche
una parte di un altro. Perciò non ci può essere lecito sostituirla con un'altra
proposizione qualsiasi avente lo stesso valore di verità.
11. È difficile esaurire tutte le
possibilità che si presentano nella lingua; spero ciò malgrado di avere
sostanzialmente rintracciato i principali motivi per causa dei quali non in
ogni caso una proposizione secondaria può venire sostituita da un'altra con lo
stesso valore di verità senza che tale sostituzione comprometta la verità di
tutto il periodo. 403
Questi
motivi sono:
- che, in certi casi, la proposizione secondaria non ha per significato un valore di verità, poiché esprime soltanto la parte di un pensiero;
- che, in altri casi, la proposizione ha bensì per significato un valore di verità, ma non si limita a esso, in quanto il suo senso non abbraccia un solo pensiero ma pure qualche parte di un altro.
Il primo
caso ha luogo:
- a) quando le parole che compongono la proposizione secondaria hanno il loro significato indiretto;
- b) quando qualche termine della proposizione secondaria, invece di essere un nome proprio, denota soltanto in forma indeterminata un oggetto.
Nel secondo
caso è possibile che la proposizione secondaria vada presa in due modi diversi,
e cioè una volta nel suo significato comune e l'altra volta in quello
indiretto; ovvero che il senso di una parte della proposizione secondaria intervenga
pure nel costituire qualche altro pensiero il quale forma - insieme col
pensiero immediatamente espresso nella proposizione secondaria - l'intero senso
delle due proposizioni, principale e secondaria.
Da tutto ciò
si ricava, con sufficiente probabilità, che i casi, nei quali una proposizione
secondaria non può venir sostituita da un'altra avente lo stesso valore di
verità, non dimostrano proprio nulla contro la tesi da noi esposta alcune
pagine addietro, e cioè contro la tesi secondo cui il valore di verità
costituisce il significato di una proposizione mentre il suo senso è costituito
da un pensiero.
12. Torniamo ora, finalmente, al
nostro punto di partenza.26
Se, in
generale, viene giudicato diverso il valore conoscitivo delle due proposizioni
a = a e a = b, questo si spiega col fatto che, in tale valore, bisogna tener
conto tanto del senso della proposizione (cioè 404 del pensiero in essa espresso),
quanto del suo significato (cioè del suo valore di verità).
Se è vera
l'uguaglianza a = b, allora il significato di b è certo identico a quello di a,
e quindi il valore di verità della proposizione a = b è identico al valore di
verità della proposizione a = a.
Ciò malgrado
il senso di b può risultare diverso da quello di a, e quindi il pensiero
espresso nella proposizione a = b può essere diverso da quello espresso in a =
a; allora anche il valore conoscitivo delle due proposizioni risulterà senza
dubbio diverso. In tale caso se conveniamo, come sopra, di intendere per
giudizio il sollevarsi dal pensiero al suo valore di verità, dovremo anche dire
che i due giudizi sono diversi.
Note
[1]
[Malgrado nella letteratura tecnica sia generalmente invalso l'uso di tradurre
il tedesco Bedeutung mediante i termini denotazione, estensione e
simili, abbiamo preferito mantenere la versione datane nella prima edizione; e
questo perché Frege stesso in una sua lettera a Peano - rimasta fino ad oggi
medita - che pubblichiamo in appendice al nostro volume, suggerisce quale
corrispondente italiano più appropriato per Bedeutung, il termine
significazione.] [[Tuttavia, si può tradurre altrettanto bene - e forse meglio
- Intensione ed estensione, che sono termini meno carichi di senso e con un
significato chiaro e distinto.
L'intensione si riferisce alla res cogitans, l'estensione alla res
extensa.]NAS] l'ultimo fra essi, il paragrafo 11, contiene un breve e utile
riassunto delle conclusioni ricavate nei cinque precedenti.]
[2]
Uso qui il termine uguaglianza [Gleichheit] nel senso di identità [Identität] e
intendo la proposizione a = b nel senso di a è lo stesso di b ovvero a e b
coincidono.
[3]
Ideografia, § 91.
[4]
[La teoria, che vede nell'uguaglianza un rapporto fra nomi, si troverebbe
quindi di fronte alla stessa difficoltà che ci fa respingere la teoria, secondo
cui l'eguaglianza è un rapporto fra oggetti: si troverebbe cioè di fronte
all'impossibilità di distinguere il valore conoscitivo delle due proposizioni a
= a e a = b.]
[5]
Per un nome proprio sul tipo di Aristotele, le opinioni circa il suo senso
possono senza dubbio differire notevolmente le une dalle altre. Eccone per
esempio due: lo scolaro di Platone e maestro di Alessandro Magno e il maestro
di Alessandro Magno nato a Stagira. Evidentemente chi accetta la prima
connetterà alla proposizione Aristotele nacque a Stagira un senso diverso di
chi condivide la seconda.* Queste oscillazioni del senso spettante a un dato
nome proprio possono risultare sopportabili esclusivamente se il significato
rimane identico; pur tuttavia bisogna evitarle nell'edificio di una scienza
rigorosa, e sarebbe opportuno non ammetterle in una lingua completa. * [Per il
primo tale proposizione esprime un fatto empirico, per il secondo invece
esprime un conseguenza immediata del senso attribuito al nome proprio
Aristotele.]
[6]
Sullo stesso piano delle rappresentazioni possiamo porre le intuizioni, per le
quali entrano in gioco direttamente le impressioni e le attività invece delle
tracce da esse lasciate nel nostro animo. La differenza è, per il nostro scopo,
irrilevante, tanto più che ci aiutano sempre a completare l'immagine intuitiva,
oltre alle nostre immediate impressioni e attività, anche i ricordi di altre
analoghe precedenti. Vi è tuttavia chi intende per intuizione qualcosa di
tutt'affatto diverso, e cioè un oggetto in quanto risulta spaziale o
percepibile con i sensi.
[7]
[Questo accenno, su cui Frege ritorna più volte, all'effettiva incontestabile
esistenza di un patrimonio di pensieri comune all'umanità, costituisce uno
degli argomenti più efficaci contro il pericolo solipsistico. Esso è
l'argomento principe cui fanno appello gli indirizzi antimetafisici per avere
il diritto di opporre, ai pretesi pensieri individuali e incomunicabili (che
non sono in grado di far uscire il soggetto da sé medesimo), altri effettivi
pensieri oggettivi e interi individuali, che formano il vero oggetto della
logica e della filosofia.]
[8]
Con il termine pensiero intendo non l'atto soggettivo del pensiero, ma il suo
contenuto oggettivo che può costituire il possesso comune di molti.
[9]
Sarebbe desiderabile disporre di un'espressione speciale per indicare i segni
che debbono avere soltanto un senso. Se, per esempio, convenissimo di chiamarli
"figure", allora le parole dell'attore nella scena sarebbero figure,
ed anzi l'attore stesso sarebbe una figura.
[10]
[La teoria, qui esposta da Frege, è stata in seguito accettata da tutti i
migliori studiosi di logica. Per essi infatti la proposizione è ciò che può
risultare vero o falso; in altri termini: se a un nesso di parole ha senso
riferire uno di questi due predicati, è lecito attribuirgli il nome di
proposizione; in caso contrario, no. Su questo si fonda tutta la logica delle
proposizioni, che costituisce senza dubbio uno dei rami più importanti della
logica formale moderna. Un cardine di essa è pure la teoria - che Frege esporrà
nel seguito del presente paragrafo - dell'equivalenza logica di tutte le
proposizioni vere.]
[11]
Un giudizio è per me non il mero concepire un pensiero, ma il riconoscimento
della sua verità.
[12] Nel periodo A finse di avere visto B, il
significato della proposizione secondaria è un pensiero, di cui si dice: I) che
A lo asserì come vero; II) che A conosceva la sua falsità.
13 [Tale scambio non influisce sul valore di
verità dell'intero periodo, sebbene il pensiero espresso dalla prima proposizione
secondaria sia falso mentre quello espresso dalla seconda è vero.]
14 [Sebbene l'espressione il pianeta che è
accompagnato ecc. abbia lo stesso significato del termine Terra, essa non può
far parte del pensiero di Colombo, dato che questi non ne conosceva il
significato.]
15 [Come, nel paragrafo 1, Frege aveva detto di
voler chiamare nome proprio una qualsiasi espressione che serva a denotare un
oggetto singolo, così ora propone di chiamare nome proprio un'espressione
(proposizione secondaria) che serva a denotare un singolo pensiero, un singolo
ordine, ecc.]
16 [Il compito della proposizione secondaria Chi
scoperse ecc. non è di affermare un fatto che può essere vero o falso (cioè
affermare che vi fu o non vi fu qualcuno che scoperse per primo tali
traiettorie), ma consiste semplicemente nel denotare un certo individuo (nel
nostro caso nel denotare Keplero). In altri termini: come la proposizioni
secondarie esaminate nel paragrafo 6 erano nomi propri di pensieri, di ordini,
ecc., così le proposizioni secondarie qui considerate sono nomi propri di
oggetti.]
17 [Dall'analisi della proposizione secondaria
Chi scoperse ecc. Frege si eleva qui ad alcune osservazioni generali della
massima importanza sulla completezza delle lingue. La sua critica fu poi
sfruttata da vari indirizzi moderni per dimostrare l'infondatezza di parecchie espressioni
metafisiche.]
18 Dopo quanto osservammo poco fa, sarebbe sempre
nostro dovere assicurare a una tale espressione un significato preciso per
mezzo di qualche opportuna convenzione. Potremmo per esempio stabilire che il
significato di tale espressione deve essere lo zero, quando sotto il suo
concetto non cada alcun oggetto o ne cada più di uno.
19 Queste proposizioni secondarie possono
peraltro venire interpretate in due modi leggermente diversi. Data per esempio
la proposizione Dopo che lo Schleswig- Holstein fu tolto alla Danimarca,
Austria e Prussia entrarono in discordia fra loro, è chiaro che noi possiamo
rendere il suo senso anche in quest'altra forma: Dopo il distacco dello
Schleswig-Holstein dalla Danimarca, Austria e Prussia entrarono in discordia
fra loro. Si vede subito che, così inteso, il senso della nostra proposizione
non contiene come sua parte il pensiero che lo Schleswig-Holstein venne una
volta tolto alla Danimarca; tale avvenimento costituisce soltanto una
condizione perché l'espressione Dopo che lo Schleswig-Holstein ecc. abbia un
significato. È certo tuttavia che esiste pure un altro modo di intendere il
senso della proposizione anzidetta: essa può infatti venire interpretata
proprio come se affermasse che una volta lo Schleswig-Holstein fu
effettivamente tolto alla Danimarca. Esamineremo in seguito questa seconda
interpretazione. Per ora ci importa chiarire bene la differenza fra le due. A
tale scopo immaginiamo di immedesimarci nell'animo di un cinese il quale - per
la sua scarsa conoscenza della storia europea - ritenga erroneo che una volta
lo Schleswig-Holstein fu tolto di fatto alla Danimarca. Potranno allora
presentarsi due possibilità: se egli accetta la prima interpretazione, riterrà
il nostro asserto né vero né falso, ma privo di qualsiasi significato, essendo
- a suo giudizio - priva di significato una proposizione secondaria di cui
l'asserto risulta costituito (questa proposizione infatti conterrebbe, secondo
lui, una determinazione temporale solo apparente); se invece accetta la seconda
interpretazione, troverà nel nostro asserto un pensiero, che egli ritiene
falso, accanto ad una parte che ritiene priva di significato.
20 [E non nel senso, preciso, che Frege attribuì
al termine giudizio nel paragrafo 5.]
21 Talvolta questo termine specifico manca, e il
significato impreciso va ricavato dal senso completo della proposizione.
[Contenendo un termine che non denota nulla di preciso, l'ipotesi da sola non
può costituire un pensiero. Altrettanto vale per la tesi. E quindi impossibile
parlare di esse come di due pensieri diversi.]
22 Lo stesso può dirsi per le congiunzione ma e
però.
23 [La relazione fra ipotesi e tesi qui accennata
da Frege riprende il famoso rapporto di implicazione materiale che Frege stesso
aveva già precisato nella sua Ideografia, e che sarà poi assunto da Bertrand
Russell alla base dei suoi Principia Mathematica. L'implicazione materiale non
denota un legame fra il contenuto di pensiero dell'ipotesi e quello della tesi;
ma esclusivamente un rapporto fra i loro valori di verità; in altri termini, in
essa è lecito sostituire una delle parti componenti con un'altra proposizione
qualsiasi avente lo stesso valore di verità.]
24 Il pensiero della nostra proposizione potrebbe
anche venire cosí espresso: O in questo momento non è ancora sorto il Sole, o
il cielo è fortemente nuvoloso. Tale nuova forma ci fa vedere come vada
concepito questo genere di collegamento fra proposizioni.
25 Questo fatto può risultare di importanza
decisiva per risolvere il problema se un dato asserto sia o no una menzogna, e
se un dato giuramento costituisca o no uno spergiuro.
26 [Malgrado la sua schematica brevità, il
paragrafo 12 è della massima importanza. Esso mostra come - dalle teorie
esposte nei primi paragrafi del capitolo e in ispecie nel paragrafo 5 - segua
nel modo più preciso la soluzione delle aporie insite nel principio di
identità. In particolare mostra come il passaggio da una proposizione a
un'altra, avente lo stesso valore di verità della prima, possa costituire un
vero progresso nella conoscenza. Così risultano chiaramente stabilite le basi
generali per una rivalutazione filosofica dei giudizi analitici (in senso
leibniziano) e quindi di tutta la logica formale.]
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
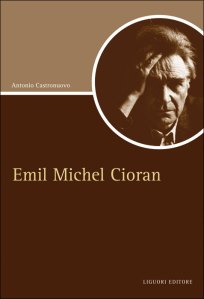

Grazie per questo bel post sui rapporti Cioran/Rigoni.
In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera (29.4.1990) Rigoni scriveva di Cioran:
«Vi sono tanti scrittori che possiamo ammirare e anche amare, ma pochi capaci di scendere nella carne e nell’anima, così da diventare complici delle nostre perplessità, dei nostri terrori o dei nostri segreti. Non è affatto abituale percepire, dietro un testo letterario, un amico. Ciò accade invece con Cioran: al punto che tanti sconosciuti, dagli angoli più disparati del globo, hanno sentito il bisogno di cercarlo – per renderlo partecipe di confidenze estreme, decisioni capitali, interrogativi ultimi o anche, semplicemente, per ridere insieme di tutto.»
Concordo pienamente.
Vorrei anche ricordare che un ruolo simile a quello svolto da Rigoni in Italia per promuovere la conoscenza di Cioran è stato svolto in Spagna dal filosofo Fernando Savater, che scrisse la sua tesi di dottorato su Cioran (ora pubblicata in italiano col titolo di “Cioran. Un angelo sterminatore” (Milano, Frassinelli 1998) e ne fu il primo traduttore in spagnolo, negli anni ’70. Savater racconta che alle sue prime traduzioni molta critica reagì pensando che “Cioran” fosse un eteronimo che lo stesso Savater usava per proteggersi (era il periodo della dittatura franchista). Savater scrisse a Cioran, dicendogli: “Sa cosa? Qui in Spagna stanno dicendo che Lei non esiste!”, al che Cioran replicò: “La prego, non li smentisca!” … risposta tipicamente cioraniana …
Sapevo che Fernando Savater (che a sua volta è scrittore di aforismi e forme brevi) aveva tradotto Cioran ma ignoravo tutta la polemica che ne è seguita. La risposta di Cioran è davvero coerente con il suo personaggio.
Credere o non credere, abbiamo detto, ma la verità è che tutti credono: distinguiamo il saggio dallo stupido comune perché crede a meno cose, varia meno frequentemente convinzioni e crede con meno intensità. (p. 36)
Ci sono sogni dai quali è improbabile o discutibile che mai si ottenga di svegliarsi individualmente, ma dai quali si può assicurare con ogni certezza che mai prescinderà la collettività umana: Dio è il più noto di essi. (p. 63)
La solitudine è la nostra materia prima: cercare di mascherarla con l’amore è come tentare di curare l’acne strofinando la pelle con una carta vetrata. Passata la prima illusione di compagnia, l’autentico effetto in profondità di ogni amore è quello di rivelarci nuovi aspetti del nostro isolamento. Ma, dato che questa rivelazione non è mai completa e dato che l’illusione si rinnova in ogni caso con forza intatta, il gioco continua all’infinito. (p. 123)
Una recente intervista a Savater sui suoi rapporti con Cioran si può leggere (in spagnolo) qui:
http://emilmcioran.blogspot.com/2010/11/entrevista-fernando-savater-por.html
Non conosco benissimo lo spagnolo, ma l’intervista a Savater è davvero molto lucida.
Cito due passi dell’intervista che sono molto importanti per comprendere la figura di Cioran:
“Tenía la pasión del estilo, como confesó —y me confesó— más de una vez… Nadie escribe como él si escribir bien no le importase. ”
El gran desengaño de Cioran es de índole religiosa, a mi parecer. Quería ser religioso, creyente, místico incluso…, pero su honradez intelectual y su sinceridad sensual se lo impidieron. Nunca se repuso de ese desengaño
Soprattutto quest’ultimo “Il grande disinganno di Cioran è di natura religiosa, a mio parere. Voleva essere religioso, credente, mistico…però la sua onestà intellettuale e la sua sincerità glielo impedirono. Non si riprese mai da questa delusione”
sono anche io un grande ammiratore di Cioran e ritengo che sia poco conosciuto rispetto al suo reale valore.
Ho letto, tra l’altro, anche il libro “Mon cher ami” citato in questo articolo, che trovo molto interessante per comprendere meglio il personaggio Cioran, la sua modestia e la sua grandezza.
Per chi non lo conoscesse bene può iniziare da questo blog:
http://letturecritiche.wordpress.com